Giona: ti sembra il caso di prendertela così?
20-09-2021, 17:54apocalittici e integrati, Bibbia, santiPermalink21 settembre – Giona, profeta suo malgrado
La Bibbia, letterariamente parlandone, non è che sia questo capolavoro: ma quello che la rende più verosimile di tanti altri libri è l'incoerenza. Bel paradosso. Non c'è dubbio che Iliade e Odissea siano più armoniche – e se poi parliamo di coerenza narrativa, Il Signore degli anelli lascia piste a tutte e tre. Ma se in giro nessuno crede più all'esistenza di Achille o Ulisse, e nessuno ha mai per un attimo preso sul serio l'esistenza di Sauron, è proprio perché si vede benissimo che sono storie con un inizio, una fine, e quasi sempre una morale. La Bibbia, beh, non proprio. La Bibbia è evidentemente una raccolta di libri scritti da mani diversissime, rivisti da traduttori e compilatori che avevano idee talvolta opposte, e messi assieme da editori che avevano criteri ancora diversi, e a fare tutto questo potrebbe esserci voluto un millennio: per cui alla fine più che una storia è uno scrigno pieno di roba che per quanto stia lì da secoli lascia sempre questa impressione di materiale raccolto alla benemeglio da qualcuno che stava scappando da un incendio, un'alluvione, una scorreria dei Caldei. Se apri l'Iliade trovi sempre duelli e litigi; se apri la Bibbia puoi trovare a distanze di poche pagine teorie sulla creazione, pagine di censimenti, storiacce di donne e predoni, dibattiti sul senso della vita, poesie d'amore, cronache storiche, profeti preoccupati dalla corruzione dei costumi, e il Libro di Giona: il quale potrebbe essere anche solo una presa in giro.
 |
| Dio parla con Giona, seduto fuori dalla città di Ninive, salterio armeno del XVII secolo, immagine di dominio pubblico |
"Libro" poi si fa per dire, sono tre o quattro paginette, ma è come se mettessero tra virgolette tutto il resto della Bibbia: e se fosse tutto uno scherzo, di Dio o di chi racconta? I cristiani lo piazzarono verso la fine dell'Antico Testamento, perché Giona sembra il profeta più vicino a una certa concezione di Gesù, e Gesù stesso a chi gli chiedeva un "segno" aveva accennato al "segno di Giona" (Matteo 12,40): così come il profeta era rimasto nel ventre di un pesce per tre giorni e tre notti, così dopo tre giorni Gesù sarebbe riemerso dal mondo dei morti. Nella Bibbia ebraica invece la storia di Giona appartiene al libro dei Profeti Minori, di cui Giona sembra però una parodia. Mentre tutti gli altri libri profetici contengono, non sorprende, profezie, quello di Giona sin dalla seconda riga dimostra al lettore che vuole essere qualcosa di diverso: un racconto. C'è da dire che l'ipotetico del lettore della Bibbia a questo punto di profezie dovrebbe averne lette centinaia, per cui dopo aver ammirato lo stile di Isaia, la verve di Geremia, la visionarietà di Ezechiele, potrebbe essere subentrata una certa stanchezza – alla fine si tratta perlopiù di ammonizioni nei confronti di uno o più popoli che non amano Dio come dovrebbero; minacce, lamenti, prefigurazioni di sventura, non è che non ci siano variazioni sul tema ma insomma la canzone è quella.
Il libro di Giona parte appunto da questa saturazione. È una specie di pausa riflessiva organizzata da qualcuno che potrebbe essere vissuto anche parecchio più tardi e che questi profeti li conosceva bene, forse li leggeva di mestiere. In Giona le profezie sono date per scontate, stanno in due righe: quello che interessa all'autore è il contesto: come si comporta il profeta che le deve enunciare, e il pubblico che le ascolta? O meglio: come ci aspettiamo che si comportino? Ipotizziamo che si comportassero in un modo diverso: cosa succederebbe? E se il profeta non avesse voglia di fare il profeta? E se il popolo, che per definizione non ascolta mai il profeta e non si pente dei propri peccati, decidesse invece di farlo? Il libro di Giona è questo: un piccolo grande What If, un esperimento mentale e narrativo. Sarà anche per questo che a differenza di tutti i cartigli profetici che lo circondano, ci suona più contemporaneo. Gli altri profeti si lamentano, minacciano, vaticinano: l'autore di Giona racconta una storia e sorride.
1,1 Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: «Alzati, va' a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me». 1,2 Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore.
Vedete, bastano davvero i primi due versetti. Il primo sembra in tutto e per tutto il classico incipit del profeta minore: il Signore parla a un Tale figlio di un altro Tale e gli ordina di andare presso la tal città di peccatori, che sta per essere distrutta come Sodoma, Gerico, Babilonia... a questo punto lo sappiamo bene cosa succede alle città che continuano a dispiacere a Dio malgrado gli avvertimenti I nomi sono presi da altri libri della Bibbia, il che tradisce l'intento narrativo: un profeta di nome Giona è brevemente menzionato nel Secondo Libro dei Re (dovrebbe essere vissuto nel IX secolo aC), mentre Ninive era stata una capitale dell'impero Assiro. Il secondo versetto spiazza tutto l'impianto, perché stavolta il profeta in questione disobbedisce: Dio gli ha dato una missione, Giona preferisce di no. Fin qui i profeti hanno sempre detto di sì al Signore, però con dubbi e timori che ci autorizzano a pensare che dire di sì al Signore sia qualcosa di faticoso, di eroico: ma l'eroismo implica una libera scelta. Se chi dice di sì al Signore è un profeta, una persona eccezionale, ne consegue che non possiamo essere tutti eccezionali, e che dunque a un uomo non eccezionale dovrebbe essere concesso rifiutarsi a Dio. Perlomeno Giona decide di scappare; il che è buffo, dato che il Signore è dappertutto.
Ma perché Giona non vuole obbedire? Non è subito chiaro, il che ha alimentato interpretazioni molto diverse, compresa quella nazionalista: Giona non vorrebbe convertire i Niniviti perché sono nemici degli Ebrei, e non tollererebbe l'idea che Dio per mezzo suo dia loro una possibilità di redimersi. È un'idea di San Girolamo, che Martin Lutero riprende in chiave antisemita: Giona rappresenterebbe l'ebreo geloso del suo Dio e dell'esclusiva alleanza che ha stretto col suo popolo. E però da nessuna parte nel piccolo libro si legge che gli Assiri stessero attaccando Israele: certo, da altri libri sappiamo che è storicamente accaduto, del resto tutti gli altri popoli nella Bibbia ci stanno apposta per attaccare e opprimere Israele. Ma l'autore non spende una sola parola per accreditare questa interpretazione: Giona non sembra avere a cuore il suo popolo o qualcun altro a parte sé stesso. È un uomo solo a cui Dio affida una missione, e che non la vuole. Può l'uomo rifiutare questo a Dio? Esiste insomma il libero arbitrio? L'autore di Giona non sembra crederci troppo: il profeta riesce a imbarcarsi, ma la nave va incontro a una furiosa tempesta. I marinai capiscono subito che un Dio ce l'ha con loro, e per riconoscere quale tirano a sorte. Viene ovviamente estratto Giona, che capisce di non avere scampo e propone di essere buttato in mare. I marinai non accettano subito l'idea: ma siccome la tempesta non cessa, si rassegnano (non dopo aver pregato il Dio di Giona perché li perdoni, loro in fondo non fanno che quello che è richiesto dalla divinità o dall'autore del racconto). Il sacrificio funziona: il mare si calma, Giona va a fondo ma Dio manda un enorme pesce a inghiottirlo.
 |
| Giona viene buttato a mare, Catacomba di Priscilla, foto di dominio pubblico |
Nel ventre del pesce Giona intona un canto di speranza che è il vertice lirico del libro: "Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce". Giona sembra avere imparato la lezione: una volta rigurgitato dal pesce sull'asciutto, riceve di nuovo dal Signore l'ordine di servizio e si reca ubbidiente a Ninive.
La città è un incubo kafkiano, troppo grande per essere vera: per percorrerla tutta servono tre giorni di cammino, insomma Los Angeles, e Giona deve attraversarla continuando ad annunciare il preavviso di Dio: "Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta". Quante possibilità ci sono che i Niniviti lo ascoltino? Se abbiamo già letto un po' di Profeti lo sappiamo: nessuna. La punizione è troppo solenne, i peccati evidentemente troppo gravi, la popolazione immensa, Giona è un uomo solo, e di malavoglia. Non possono salvarsi, è troppo tardi.
Ma se invece decidessero di ascoltare il Signore? Perché per la prima volta in tutto l'Antico Testamento, l'autore sceglie di percorrere questa via. I Niniviti si pentono tutti, dal primo all'ultimo e persino gli animali; lo stesso re smonta dal trono e si affretta a emanare un editto in cui impone a cittadini (e persino gli animali) di astenersi dal cibo, vestire di sacco ed espiare i gravi peccati che, tra l'altro, nessuno ha ancora spiegato quali siano, sono soltanto un mcGuffin per fare andare avanti la storia. Del resto, se Dio ha mandato Giona, significa appunto che voleva dare ai Niniviti un'ultima possibilità; se i Niniviti approfittano della possibilità, Dio non può che "pentirsi del male che aveva minacciato di far loro" e revocare la distruzione. Tutto è bene quel che finisce bene – salvo che Giona preferirebbe di no. È offeso a morte.
Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: "Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!"
Che senso ha una scenata del genere? Se lo domanda persino Dio: "Ti sembra giusto essere sdegnato così?" Una spiegazione è sempre quella nazionalista: i Niniviti sono nemici degli Israeliti e per averli salvati Giona si sente ora un traditore dei suoi... ma non convince. Forse Giona è scontento perché il libero arbitrio sembra andare in una sola direzione: Giona non era libero di sottrarsi alla missione, mentre i Niniviti sembrano liberi di sottrarsi col proprio pentimento a una catastrofe che Dio aveva già predisposto per loro. Oppure, semplicemente, a Giona l'idea di una catastrofe non dispiaceva. In effetti anche dopo il perdono di Dio, che cosa fa? Esattamente quello che ci aspetteremmo dal classico profeta di sventura: esce dalle mura e resta a una prudente distanza, a osservare se per caso non arriva un terremoto o un diluvio o un fulmine. E intanto chiede a Dio la morte.
Questa posa querula e accigliata è la definitiva presa in giro dell'atteggiamento convenzionale del profeta: l'autore di Giona li conosce bene e forse ha cominciato a domandarsi se sotto le loro barbe non covi una certa ipocrisia. È davvero così affranto, il profeta-tipo, di vedere il popolo andare in malora? Non ci sta provando gusto, perché questo lo rassicura del suo essere migliore? E questo compiacimento interiore, la sicurezza di avere ragione mentre il popolo sguazza nel torto, sarà cosa davvero gradita a Dio? Lo stesso Dio, da che parte dovrebbe stare: col profeta che si sente l'unico uomo giusto, o con un popolo peccatore che riconoscesse i suoi errori?
 |
| Giona e la balena, di Pieter Lastman, riproduzione di dominio pubblico (non lo sta inghiottendo, lo sta rigurgitando). |
Dio ha salvato una città, anche grazie al lavoro di Giona: ma Giona avrebbe preferito di no. È stanco, ha la sensazione di avere lavorato molto senza ottenere quello che per un profeta è lecito attendersi: un bel disastro da contemplare sdegnato all'orizzonte. Fa anche un po' caldo, Giona cerca di ripararsi ma non c'è molta frasca nel deserto. Dio allora fa crescere per lui una pianta – non sappiamo di che specie, perché il suo nome, kikayon, compare solo qui in tutta la Bibbia. Spesso è tradotta come il ricino, ma non è così importante. L'importante è che questa pianta dà a Giona un po' di sollievo, addirittura di gioia. Allora Dio la uccide.
Sembra veramente che Dio se la prenda soltanto con Giona: tutti gli altri meritano il suo perdono, che siano marinai pagani o Niniviti peccatori. Solo Giona viene sempre tormentato, e quando ricomincia a lagnarsene, Dio ha la faccia tosta di chiederglielo: ma ti sembra il caso di lamentarti per una semplice pianta di ricino? Giona conferma di sì, che è sdegnato al punto di morirne: solo allora Dio gli svela di essere non essere che il protagonista di una parabola, un brontolone ideato apposta per servirGli su un piatto d'argento la risposta finale.
«Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita: e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?»
L'Antico Testamento sta per cedere il passo al Nuovo: il Dio che nei primi libri sembrava una presenza terribile, gelosa e vendicativa sembra diventato un altro, una persona talvolta imprevedibile ma di buon senso, disponibile a rivedere le sue decisioni, più affezionato ai peccatori che a chi fa loro tutto il tempo la morale. Ama persino gli animali, il Libro finisce con questa precisazione che sembra un'inezia e non lo è: anche loro si sono pentiti, anche loro meritano il perdono. Tutti lo meritano, persino Giona che dovrebbe scendere dal suo piedistallo e capire che Dio sta facendo per Ninive quello che ha fatto per lui quando era nel pesce: offrire una seconda possibilità. Se i primi autori della Bibbia avevano chiaramente un rapporto complesso con padri autoritari e bizzosi, si intuisce che i tempi sono cambiati, i padri si sono addolciti o comunque si sente in giro la necessità di padri buoni, misericordiosi, persino un po' ironici, padri che abbiano creato il mondo perché questo li rendeva felici, come l'ombra ci rende felici quando siamo nel deserto.
Non sappiamo se Giona abbia imparato la lezione: l'importante è che l'abbia intesa il lettore. Subito dopo comincia il Libro di Michea, un altro rotolo di furenti minacce per le genti di Samaria e Gerusalemme che non ascoltano la Parola del Signore. Insomma è stata solo una pausa di riflessione. Molto utile, per me almeno. Spero anche per voi.
I falsi e i veri lemming
15-08-2021, 02:07apocalittici e integrati, epidemia 2020, filosofia, genetica no ambiente sìPermalinkNon so quanto c'entri con quanto detto fin qui, ma invecchiando mi scopro sempre più determinista genetico. Si tratta a dire il vero di una tendenza con cui combatto sin da quando sono cosciente (credo di averlo scritto all'inizio di questo sito web): io tra gene e ambiente sono uno che ha deciso di tifare ambiente non perché sia convinto che il gene sia meno importante, anzi il contrario; è solo che sul gene mi rifiuto di intervenire, il Novecento mi sembra un monito significativo in tal senso, e quindi se voglio modificare la società non mi resta che intervenire sull'ambiente - ma con gli anni si ingrossa il dubbio che più che una scelta sia un ripiego. Anche la paternità avrà avuto il suo peso: a un certo punto non ci puoi fare niente, vedi i tuoi geni che se ne vanno in giro e per quanto cerchi di evitar loro tutta una serie di guai che a questo punto indovini benissimo, ti rendi conto che non ci puoi far niente, è come aver caricato un giocattolo a molla, ma sto divagando.
Invecchiando divento sempre più darwiniano, come gli "scienziati" dei giornali di quando ero bambino che ogni settimana scoprivano il gene di qualcosa di diverso (il che mi innervosiva immensamente): il gene della fantasia, il gene dell'originalità, a un certo punto scoprirono pure il gene dell'omosessualità, il che mi perplesse molto perché non capivo come potesse diventare dominante (in seguito forse ho capito). Adesso che queste cose mi sembra vadano molto meno di moda, sono io che invece continuo a osservare i miei simili e fantasticare continuamente di vantaggi evolutivi. Vedo un falò: come quando ero bambino, il fuoco mi ipnotizza, potrei passare ore a guardarlo. Penso a quanto fu fantastico a un certo punto trovarsi un camino in casa, imparare ad accenderlo, rischiare la vita centinaia di volte, puzzare di fumo, scottarsi la lingua con le caldarroste, ora so che nel frattempo inquinavamo l'ambiente più che con il turbodiesel, ma poi crescendo vedevo i miei compagni di scoutismo che non avevano un camino in casa restare ipnotizzati davanti allo stesso sortilegio nel quale io ormai mi destreggiavo, mentre loro rischiavano di bruciarsi le ali come insetti intorno a una lampadina. Ma non faccio in tempo a formulare il ricordo che sto già pensando al vantaggio evolutivo che premiò i miei antenati che invece di scappare davanti a un tronco colpito da un fulmine ebbero la pazza idea di restare nei pressi e cercare di capire come funzionava, folli! chissà quanti ne morirono, e malissimo! ma poi venne qualche glaciazione e alla fine chi sopravvisse furono proprio i folli piromani, che poi siamo noi, chi più chi meno. E così via. Una volta penso al fuoco, un altra volta al rumore, in generale a qualsiasi cosa apparentemente fastidiosa e pericolosa ma in sostanza vitale, che risvegli in noi sia la paura, sia il desiderio di sopraffarla.
A volte penso ai lemming: e anch'io non penso a quelli veri, ma a quelli che a un certo punto l'uomo si è inventato, quelli che decidono di sterminarsi. Chiunque abbia formulato la leggenda, è chiaro che aveva in mente più i suoi simili che qualche roditore dei ghiacci. Stava cercando un modo per descrivere le psicosi collettive, crociate dei fanciulli, le guerre inutili (cioè tutte, viste dalla debita distanza), tutte quelle situazioni in cui una massa di persone sembra volersi annientare e c'è sempre un metodo, nella loro follia: c'è sempre la convinzione di rendere al resto dell'umanità qualcosa di utile. Tra le tante leggende che serpeggiano nel sottobosco dei noVax, una delle più rivelatrici mi sembra quella che vede nel vaccino un espediente creato da Bill Gates, il quale, dopo aver calcolato che l'umanità deve ridursi del 10%, ha prima introdotto il virus per spaventarci, e poi il finto vaccino che opererà questa demoniaca riduzione. (Prevedo l'obiezione: ma Bill non poteva semplicemente ammazzarci con un virus, invece di tutta questa manfrina? Probabilmente all'inizio la leggenda non prevedeva il vaccino, e poi si è adattata alla situazione).
La leggenda suona simile a quelle fiorite in ambito sciachimista (le scie chimiche sarebbero parte di un piano per ridurre la fertilità). Sono tutti spettri malthusiani e c'è da domandarsi se non siano persino ottimisti: magari bastasse ridurre la popolazione del 10%, magari bastasse spargere un po' di bromuro per risolvere la sovrappopolazione e il surriscaldamento. Ma quel che mi ipnotizza di queste fantasie, come il fuoco quand'ero bambino, è l'inferno interiore che rivelano: non è Bill Gates che vuole ridurre la popolazione, sono loro che inconsapevolmente ci stanno provando. Sono gli apostoli del Covid, che molti ancora non hanno preso ma non vedono l'ora e faranno tutto quello che possono per passarlo ai loro cari, ai colleghi, agli studenti. Quando ci fu il lockdown non sopportavano il lockdown, il che è comprensibile perché durò mesi: ma loro erano già a spasso a starnutire fuori dalla mascherina dopo due settimane. Quando arrivarono i vaccini, decisero immediatamente che erano sieri sperimentali non sperimentati abbastanza, e ora eccoli in piazza a intervalli regolari, inconsapevolmente decisi a creare almeno un focolaio in ogni città. Se davvero Bill Gates fosse il Thanos della leggenda, è loro che finanzierebbe e ispirerebbe: e qualcuno del resto li ispira davvero, lo si intravede nel modo in cui a raggiera condividono i loro slogan. Ma potrebbe anche non esserci nessun grande vecchio dietro, potrebbe essere l'istinto a guidarli verso i crepacci; la follia che apparentemente li contagia potrebbe essere un vantaggio evolutivo.
Forse sopravviviamo come specie perché ogni tanto una parte di noi oscuramente avverte di aver saturato il proprio ambiente naturale e si autodistrugge. Forse il diluvio l'abbiamo causato noi, disboscando qualche altura di troppo; di certo la crisi del Trecento l'abbiamo causata noi (anche in quel caso sovrappopolazione e disboscamento, ancora prima che arrivasse la peste). Quando si può fare una guerra, la facciamo; ma in molti posti non si può fare più, causerebbe la mutua distruzione, e allora ritorniamo ad altri sistemi già testati e attestati, come la pestilenza. Ma se è quello che sta succedendo, che senso ha provare a ragionare coi noVax? Non solo il loro comportamento è istintivo, ma cosa ci sarebbe poi di sbagliato nel loro istinto? La scienza e la politica stanno cercando di salvare più umanità possibile, nel solito goffo modo, con le goffe equazioni utilitariste per cui la vita di due uomini dovrebbe essere meglio della vita di uno solo eccetera. I lemming inconsapevolmente intuiscono che l'umanità si salva in un altro modo: potando molti rami per salvare il fusto. La politica non saprebbe che rami potare, i regimi totalitaristi forse possono abbozzare un piano ma le democrazie non sono in grado di sostenere calcoli di questo genere, sono intelligenze fragili che vanno in crash al primo dilemma del trolley. I lemming non fanno calcoli, non cercano di salvare sé stessi o i loro congiunti (ovvero, proprio mentre credono di salvare sé stessi, si proiettano più direttamente nei crepacci). Il loro unico piano è scritto nei loro geni, come una bomba a tempo. Sì, qualcuno di loro è convinto di essere intelligente, alcuni sono intelligenti addirittura di mestiere e sono convinti di avere un sacco di argomenti per mandare i simili al massacro. Hanno studiato il Novecento e quindi si aspettano che si ripeta prima o poi, non necessariamente in farsa. Ma non sono i capibranco, raramente li vedi in testa a una colonna di roditori, insomma è inutile prendersela con loro. Sono meno intelligenti di quel che credono? In un certo senso sì. Non capiscono quello che stanno facendo? Non del tutto. Hanno torto a fare quello che stanno facendo? Non lo so, vedremo.
Il poeta preferito di Gesù
09-05-2021, 11:36apocalittici e integrati, Bibbia, Cristo, ebraismo, santiPermalink9 maggio – Isaia, profeta e poeta

Sappiamo che Gesù sapeva leggere (Luca 4,16). Conosciamo anche il suo scrittore preferito. Basta ascoltare quel che dice, basta ragionare su quel che fa: Gesù è un lettore di Isaia. Lo conosceva bene, lo citava spesso, a volte forse gli usciva di bocca senza neanche che se ne accorgesse. Si vede che lo aveva letto molto. Un lettore laico e spassionato potrebbe aggiungere: lo aveva letto troppo. Isaia potrebbe avergli fatto l'effetto che Chateaubriand e Balzac facevano a Emma Bovary; potrebbe averlo ridotto nel modo in cui i poemi cavallereschi ridussero Don Chisciotte. I Profeti avevano descritto il mondo, ma ora si trattava di cambiarlo: dopo aver letto Isaia, meditato Isaia, sognato Isaia, il carpentiere di Nazareth a un certo punto decise di vivere Isaia. Questo significava anche vivere poco, cosa di cui forse non si rese conto che in seguito.
 |
| Don Chisciotte e Sancio Panza (Honoré Daumier). |
Del resto di che autore ci si poteva appassionare, nella Galilea del primo secolo? Parlando di poesia, la Bibbia non è che ne trabocchi. Qualche salmo ispirato (i migliori assomigliano proprio allo stile di Isaia), qualche proverbio azzeccato, un paio di libri che ancora oggi ci sorprendono (Qohelet, Giobbe), e il resto è prosa. La poesia del resto non era lo scopo iniziale dei redattori e dei compilatori. In principio c'era soprattutto da fare storytelling, world building, mettere insieme un po' di leggende e raccontarle in modo non troppo romanzesco e non troppo infantile, tagliando le contraddizioni, gli errori di continuity. Poi – siccome si parla di un contratto tra Dio e il suo popolo – c'è tutto il capitolato, le leggi e le norme e persino le risultanze di un censimento. Sono le pagine meno eccitanti, ma danno un tocco di realismo. Ai primi cinque libri, attribuiti a Mosè e chiamati Torah, "insegnamento", seguono i Neviìm, i Profeti, una raccolta che all'inizio sembra voler proseguire il racconto storico. Documentano l'invasione della Terra Promessa (Libro di Giosuè), il successivo periodo anarco-tribale (Libro dei Giudici), la nascita di una monarchia unitaria (Libro di Samuele), il momento di massima gloria con l'erezione del tempio di Salomone, la secessione tra regni di Israele e Giuda, la decadenza e le ripetute sconfitte belliche, fino alla deportazione degli ebrei in Babilonia (Libro dei Re), il vero momento cruciale di tutta la Bibbia: l'esodo al contrario.
Qui si interrompe la storia del passato e comincia quella del futuro. La seconda parte infatti ospita i libri più propriamente profetici: Isaia, Geremia, Ezechiele, i Minori. E anche se questi profeti testimoniano da punti di vista diversi la stessa storia contenuta nella prima parte, la descrivono come se dovesse ancora accadere e i migliori ci restituiscono proprio questa sensazione: che tutto debba ancora accadere. Gli ebrei non sono ancora in Babilonia, i cantori del Tempio devono ancora appendere le cetre alle fronde dei salici. Persino gli Assiri devono ancora devastare il Paese da nord. Tutto è già scritto, eppure tutto deve ancora succedere e attenzione: potrebbe ancora non succedere. Dipende dal Popolo Eletto, nel quale il lettore tende a identificarsi, non fosse altro perché come accade nei romanzi di formazione egli è il prediletto di Qualcuno ma ha un'inveterata tendenza a non seguirlo e cacciarsi nei guai. Se solo smettesse di sacrificare a idoli falsi, se solo riconoscesse il Signore come unico Dio, se solo cominciasse a onorarlo come si onora un buon padre, e rispettasse i suoi insegnamenti... e mentre leggiamo sappiamo che non succederà; non quella volta almeno; ma capiamo anche che stavolta tocca a noi.
Come notava un lettore attento come Girolamo, lo stile di Isaia è così lucido che il suo futuro sembra già un passato. Come ha suggerito qualche critico in seguito, questo potrebbe dipendere banalmente dal fatto che le profezie di Isaia sono profezie post eventum, ovvero scritte (o rieditate) dopo i disastri che illustrano. Questo è probabilmente vero per tante pagine in cui si dà conto delle scorrerie degli Assiri e poi della dominazione Babilonese, e persino del successivo periodo Persiano (c'è persino un cantico in onore di Ciro scià di Persia, liberatore di Israele). Sappiamo che Isaia, chiunque fosse, viveva in un piccolo regno destinato a cadere come un vaso di coccio tra i vasi di ferro del tempo, gli imperi che in una fase di crisi tendevano a estendere il loro controllo sulle zone periferiche. Così succedeva ciclicamente da secoli: poco a est di Gerusalemme si potevano vedere le rovine di misteriose città già millenarie come Gerico; fantasticare sul Dio terribile che doveva averle distrutte e sui peccati immondi che gli antichi cittadini dovevano avere commesso per meritare tanta vendetta. La raccolta di Isaia comincia con uno dei brani più scioccanti, dando voce a un Dio letteralmente stomacato dal fumo di sacrifici che non può apprezzare.
"Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. [...] Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me; noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue!" (Isaia 1,11-15).
 |
| L'Isaia di Michelangelo, con quei piedoni impressionanti (Cappella Sistina). |
Questo Dio deluso e arrabbiato, al lettore della Bibbia ormai è familiare. Eppure nessuno gli ha prestato la voce così bene come il profeta-poeta Isaia, al punto da avvalorare il sospetto che sia lui ad averlo immaginato per primo, nell'VIII secolo avanti Cristo, in un luogo e in un tempo in cui il più rigido monoteismo era ancora in fase di formulazione. Gli idoli di pietra legno e gesso (Isaia 44), sono ancora divinità stimate e adorate da gran parte della popolazione; l'idea di rigettarli come manufatti, distruggerli e imporre un unico Dio non rappresentabile è promossa dalla corte di Gerusalemme, presso la quale l'Isaia storico dovrebbe avere avuto un ruolo ufficiale. Se fosse nato nel 765, avrebbe potuto assistere direttamente o indirettamente alla catastrofe del 722: l'invasione assira che pose termine al Regno di Israele di Samaria e Galilea e alla deportazione delle Dieci Tribù Perdute. In seguito gli assiri si sarebbero spinti fino a Gerusalemme; ma proprio le preghiere di Isaia e del pio re Ezechia avrebbero sgominato l'esercito invasore, causando 185mila morti in una notte (38,36). Se questo dettaglio appare poco verosimile, in compenso gli archeologi hanno scoperto che negli anni seguenti all'invasione Assira la popolazione di Gerusalemme e dintorni crebbe drasticamente, probabilmente perché molti ebrei dei territori occupati a nord si erano riversati a sud. Le distruzioni che Isaia immagina, potrebbe averle viste davvero, o essersele fatte raccontare da qualche profugo. Non sono ancora immaginazioni apocalittiche e macchinose come nei profeti più tardi: sono papiri impestati di lacrime sincere, dolore autentico e autentica angoscia perché Isaia e i suoi seguaci hanno la sensazione che tutto possa succedere di nuovo, se Israele non capisce la lezione.
In quel giorno, sette donne afferreranno un uomo e diranno: "Noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti; facci solo portare il tuo nome! Togli via da noi il disonore!" (4,1).
Dopo il ritiro degli Assiri, Isaia fa ancora in tempo ad avvertire re Ezechia che Gerusalemme sarà preda dei Babilonesi (39,5); Ezechia però ormai è anziano e si addirittura si rallegra – tratto dissonante e verosimile – perché ci vorrà ancora qualche generazione e lui non ci sarà più (39,8).
Il profeta invece va avanti, anche se non è più l'Isaia storico (secondo una leggenda il successore di Ezechia, l'empio Manasse, lo avrebbe fatto segare in due nel tronco dove si era nascosto). Metà del suo libro in effetti è da attribuire a una "scuola di Isaia", un seguito di discepoli che condivide col maestro non solo il monoteismo rigoroso e l'angoscia per il futuro, ma anche lo stile. I discepoli riprendono anche il concetto messianico, l'idea che le sorti di Israele dipendano da un prescelto. Il maestro aveva previsto che nascesse da una vergine, lo aveva chiamato Emanuele ("Dio con noi"), (7,14) e lo aveva collegato alla dinastia reale di Giuda (il "tronco di Iesse", padre di David, 11,1). Nei papiri dei successori il Messia diventa una figura più drammatica, assume il titolo di "Servo del Signore" e assume i tratti di una vittima sacrificale. "Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità" (53,4-5).

Le profezie del libro si estendono per tre secoli, fino al ritorno degli ebrei da Babilonia consentito dallo scià Ciro il Grande a partire dal 538 aC. E anche in seguito, perché mentre i libri storici fanno il loro tempo, un buon libro di poesia è per sempre: cinque secoli dopo ancora Gesù ci trovava qualcosa di fresco e interessante. Sarebbe mai uscito da Nazareth, avrebbe mai abbandonato la stabile attività di carpentiere, se a un certo punto non si fosse lasciato conquistare dall'idea di un Regno di rettitudine dove l'agnello riposerà col leone? Se in lui non avesse iniziato a serpeggiare il sospetto di essere lui il Servo del Signore, il prescelto che doveva essere schernito e flagellato prima di portare la giustizia sulla terra? Persino quella scelta discutibile di consegnarsi alle guardie del Sinedrio; di farsi processare davanti a un procuratore Romano senza dire una parola a sua difesa, assume un senso se si rilegge Isaia 53. Gesù potrebbe aver semplicemente amato così tanto le profezie di quel libro da decidere di realizzarle – a prezzo della sua vita, certo, i lettori veramente affezionati queste cose le fanno.
E se fosse davvero andata così, questo cosa ci insegnerebbe: che la Bibbia è un equivoco? Un profeta del settimo secolo scrive una serie di messaggi per mettere in guardia politici e credenti da una possibile invasione da nord e sulla necessità di stringersi intorno al monarca di una dinastia blasonata; però li scrive così bene che secoli dopo la gente continua a leggere i suoi versetti completamente decontestualizzati, continua ad aspettare un Messia anche se la stirpe di David si è estinta, e a sognare la caduta di Babilonia – Babilonia nel frattempo è effettivamente caduta, ma Isaia è così bravo a scriverne che speriamo tutti che si riferisca a qualche altra città tronfia e arrogante, speriamo tutti che ancora si realizzi, lo speriamo così tanto che ogni tanto succede, e ogni volta che succede è la prova che Isaia non sbagliava. Il suo libro è una profezia che si autoavvera.
 |
| Gabriele "D'Annunzio" Rapagnetta |
I poeti hanno spesso ragione. Suona un po' retorico e molto crociano, ma se ci riflettete. Tutto quello che a distanza di secoli riconosciamo come poesia, è sempre qualcosa di talmente lucido che riusciamo a specchiarci. Noi in teoria non abbiamo più nulla in comune con Publio Virgilio Marone, ma agnosco veteris vestigia flammae sappiamo tutti cosa vuol dire, sappiamo tutti che è vero e lo è per tutti noi, e lo sarà ancora per qualche generazione. E se non piangi, di che pianger suoli? Di me medesmo meco mi vergogno. Ô vraiment marâtre Nature. The bustle in a house the morning after death. E l'infinita vanità del tutto. I poeti dicono la verità, tranne ovviamente D'Annunzio. No, in realtà la maggior parte dice sciocchezze (come D'Annunzio), e infatti smettiamo di leggerli, perché dopo un po' le pietre colorate ci stancano, mentre di quelle che ci specchiano non ci liberiamo mai. Per distinguere il diamante dal coccio di vetro, più che occhio e gusto ci vuole tempo, tantissimo tempo. È peggio che piantar datteri: tu verga pure i tuoi versicoli e spera che ogni tanto qualcuno li ristampi, ma già sai che ci vorranno secoli per capire se hai eretto davvero un monumentum aere perennium, o sottoscritto tonnellate di carta da macero.
Isaia ce l'ha fatta. Anche se non avete mai aperto una Bibbia in vita vostra: ugualmente qualche suo verso lo conoscete, e vivete in un mondo cambiato dai lettori di Isaia. Oppure avete visto Matrix, o qualsiasi altra saga che abbia per protagonista il Prescelto, ecco: quella è un'idea di Isaia. Potrebbe essere il poeta più antico che conoscete: se la gioca con Omero. Quest'ultimo è senz'altro un miglior narratore, un più attento osservatore, soprattutto quando c'è da descrivere fatti di sangue cui deve avere assistito direttamente. Isaia è meno trucido: la violenza non lo attira, preferirebbe che i nemici fossero annientati direttamente da Dio nel modo più astratto e pietoso possibile, senza spargimenti di sangue. Insomma non ha fatto il militare, Isaia; ma ci ha regalato in fondo a tanti papiri intrisi d'angoscia l'immagine di un mondo di pace e soprattutto l'ipotesi che quel mondo non sia un ricordo di un passato perduto – come per i Greci e poi per i Romani – ma qualcosa che può ancora avvenire: un seme che darà frutto, un regno di rettitudine.
"Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro; liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà il beffardo, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla" (29,17-22).
È un'idea per cui vivere, anche se spesso si tratta di vivere tragicamente e poco. Ma è un'idea. Isaia l'ha immaginata, Gesù l'ha vissuta, i suoi seguaci hanno continuato a imitarlo per secoli, ed eccoci qui. Babilonia può cadere da un giorno all'altro, Dio lo ha già fatto più volte, può rifarlo. Dipende solo da noi. Il Signore ha già spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro. Riposa ora tranquilla tutta la terra: ed erompe in grida di gioia.
Geremia, e altre geremiadi
30-04-2021, 21:22apocalittici e integrati, Bibbia, ebraismo, santiPermalink1 maggio – Geremia, profeta (650-580 aC)
A Geremia capitò, nel quinto mese del quarto anno di Sedecia (ultimo re di Giuda), di essere contestato pubblicamente da un altro profeta, Anania figlio di Azzùr, da Gàbaon. Nel tempio di Gerusalemme, sotto gli occhi dei sacerdoti e del popolo, Anania annunciò che la dominazione babilonese aveva i giorni contati; nel giro di due anni i deportati a Babilonia sarebbero tornati a casa, gli arredi saccheggiati restituiti al Tempio. Ora Geremia da anni non faceva che spiegare il contrario: contro i Babilonesi di Nabucodonosor II ogni resistenza era inutile, e soprattutto contraria al volere dell'unico Dio. E siccome alle sue parole nessuno sembrava volersi rassegnare, Geremia aveva tentato con il linguaggio degli oggetti; si era fatto montare sul collo un giogo (Geremia 27,2), come una bestia di soma, e con quel giogo sul collo, emblema dell'egemonia babilonese, si recava nel Tempio a testimoniare la volontà del Signore. Finché non arriva questo Anania da Gabaon e non osa spezzargli il giogo davanti a tutti, gridando: "Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io romperò il giogo del re di Babilonia!" (28,2). E Geremia?
 |
| Il Geremia di Michelangelo (Cappella Sistina). |
E Geremia non oppone resistenza, anzi, per un attimo sembra lasciarsi convincere. "Così sia! Così faccia il Signore! Voglia il Signore realizzare le cose che hai predette", risponde ad Anania (28,5). Credo sia l'unico caso un tutta la Bibbia in cui profeta afferma che preferirebbe aver torto, che si verificassero le profezie di qualcun altro. Geremia aggiunge però un'obiezione. Da sempre, spiega ad Anania, i profeti annunziano sventure: "guerra, fame e peste". Un profeta di cose buone è una relativa novità e quindi "sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà" (28,8): insomma circostanze eccezionali (la pace, la vittoria contro i nemici) richiedono prove eccezionali. Poi Geremia "se ne va per la sua strada" (28,11), magari in cuor suo sperando che il Signore queste prove le fornisca, che il Signore per una volta confermi il profeta di pace e sbugiardi lui e tutti i colleghi uccelli del malaugurio. Niente da fare: appena il Signore gli rivolge la parola è per rivolgere un messaggio ad Anania: "Tu hai rotto un giogo di legno ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro" (28,13). Anania muore di lì a poco, e nel giro di qualche anno Nabucodonosor, innervosito dalle tresche di Sedecia con gli Egizi, rimanda le sue truppe a Gerusalemme, distrugge il Tempio, completa la deportazione. Geremia non sbagliava mai. Ma ecco, non ci provava gusto. È un dettaglio importante.
"Da grande penso che farò il profeta", Linus avverte Charlie Brown in una striscia del 1970. "Dirò verità profonde, ma nessuno mi ascolterà". "Se nessuno ti ascolterà, perché parlare?" "Noi profeti siamo molto ostinati" ("stubborn"). Tutt'altro che digiuno di Scritture, Linus ha un'immagine ben precisa di che tipo di profeta vuole essere. Non un'autorità sacerdotale come Samuele, né un supereroe come Elia. Non un detective sagace e integerrimo come Daniele, non un poeta ispirato come Isaia né allucinato come Ezechiele. Per Linus essere profeti significa soprattutto essere "ostinati": significa essere Geremia. È lui il profeta tipo. Gli altri sono troppo lirici, o visionari, o protagonisti di storie epiche o edificanti. Geremia non è un personaggio, è un uomo. Dio lo ha scelto per recare notizie perlopiù cattive, senza riguardo per la salute del messaggero. Malgrado sia predestinato dalla nascita ("Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo... ti ho stabilito profeta delle nazioni", 1,5), Geremia sin dall'inizio si schermisce ("Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane", 1,6). Ma non c'è niente da fare. "Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me" (20,7). Per forza: ogni volta che parla, deve proclamare: "Violenza! Oppressione!", ed è il primo a stancarsene. Dio gli invia profezie non solo per Giuda, ma per tutte le nazioni grandi e piccole: e sono tutti oracoli di sventura, tutti messaggi pericolosi. Non può nemmeno sposarsi. "Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno" (20,8).

Geremia ha una verità dura da consegnare: il popolo di Giuda sarà punito per i suoi peccati. Esso ha abbandonato l'unico Dio, rivolgendosi a idoli osceni come Baal, che talvolta pretendono ancora sacrifici umani (19,5). Il Signore non li ha mai richiesti, anzi ne è orripilato. Se il popolo non ascolta Geremia, l'invasione da nord sarà inevitabile. "Ecco, io porrò per questo popolo pietre di inciampo, in esse inciamperanno insieme padri e figli; vicini e amici periranno" (6,21). È chiaro che con un messaggio simile Geremia rischiava di passare per un agitatore al soldo dell'invasore ("Tu passi ai Caldei!", 37,13). Il suo libro non si dà molta pena di confutare questa impressione: più volte arrestato e fustigato dai funzionari del re di Giuda, gettato in una cisterna dove rischia di morire di sete e fame (38,6), Geremia viene liberato proprio dai Babilonesi ed è lo stesso Nabucodonosor a fornirgli una scorta armata (39,12). Mentre re Sedecia viene imprigionato a Babilonia (l'ultima cosa che vede, prima di essere accecato, sono i suoi figli sgozzati dal boia), a Geremia è risparmiata anche la deportazione in Mesopotamia, dove fu condotta gran parte della classe dirigente del regno di Giuda. Geremia scrisse loro di non preoccuparsi, di far figli e accettare la nuova situazione, comunque transitoria: anche Babilonia sarebbe caduta, nel giro di settant'anni. Non sbagliava nemmeno su questo, ma è forte il sospetto che questa e altre profezie siano ritoccate a posteriori dagli scribi. Il suo libro, uno dei più disordinati della Bibbia, mescola gli oracoli a episodi di vita vissuta, con enormi lacune e vistose ripetizioni. Proprio questo disordine ci dà la sensazione che quella di Geremia sia storia, ambigua e incompleta com'è sempre la storia, e non una favola a lieto fine. Elia è probabilmente un mito, Isaia il nom de plume di più poeti, Giona un racconto edificante: ma Geremia dev'essere esistito davvero. La cisterna in cui viene gettato sembra molto più vera di quella già traslata in fiaba in cui i figli di Giacobbe gettano il fratello Giuseppe; o l'immaginosa fossa dei leoni, in cui un imperatore di fiaba getta il profeta Daniele. Geremia potrebbe essere il modello umano di tanti eroi biblici, compreso Mosè che come lui è scelto da Dio anche all'inizio se non sa parlare. Anche Giobbe, che brontola il suo destino in una discarica di fango e cenere, gli somiglia un poco; così come il profeta Osea a cui Dio dà però il permesso di sposarsi (purché con una prostituta). Giona invece è già una parodia.
Geremia era il mio profeta preferito, da ragazzino – affermazione patetica, mi rendo conto, ma a qualcuno potrebbe essere utile sapere che i bambini pensosi che cercano ruoli modello nell'Antico Testamento non sono soltanto una fantasia di Charles M. Schulz; che per esempio io a dodici anni mi misi a leggere la Bibbia, così, perché Harry Potter non era ancora stato pubblicato, per provare a me stesso che ne ero capace, e perché a dire le solite preghiere mi annoiavo. La lessi tutta un paio di volte e mi annoiai comunque molto – specie coi Numeri e i Profeti, che con i loro annunci di sventure sono parecchio ripetitivi. Perfino il sublime Isaia, letto a dodici anni nel dopopranzo in attesa di DJ Television, non rendeva quanto avrebbe dovuto. Ma in generale lo potrei dire per quasi tutti i libri migliori che ho letto: li ho letti troppo presto, troppo in fretta, senza capirci troppo; però almeno li ho letti. Geremia era il mio preferito perché mi sembrava davvero solo contro tutti, con una verità catastrofica ma necessaria, da somministrare a un popolo ottuso. È imbarazzante, ma in lui mi riconoscevo. Bastava accendere la tv – e l'accendevo subito dopo – per trovarmi davanti a un'umanità garrula che rideva, ballava inconsapevole su una polveriera di euromissili. Poveri stolti, mi dicevo, e avrei voluto come Geremia recarmi da tutti i potenti della Terra con un calice di amare rivelazioni, da ingollare fino alla feccia (4,28). "Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Bevete e inebriatevi, vomitate e cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se poi rifiuteranno di prendere dalla tua mano il calice da bere, tu dirai loro: Dice il Signore degli eserciti: Certamente berrete!"
 |
| Poi posavo il Libro, accendevo la tv e c'era lui, il sacerdote del Serpente. |
Quel che più mi faceva infuriare è che anch'io, anch'io avrei dovuto pagare le conseguenze dello sconsiderato ottimismo della generazione che mi precedeva: "i padri mangiarono l'uva acerba e i denti dei figli rimasero allegati", avrebbe detto Geremia (31,29). È il concetto di colpa collettiva, che il profeta mette nero su bianco sui suoi papiri; la causa delle disgrazie dei contemporanei è sempre l'empietà dei genitori. Dio non tratta con gli individui, ma coi popoli: la condanna è collettiva e cosi è il perdono, che può subentrare soltanto se tutta la collettività muta il suo comportamento. Nessuno si salva da solo, nemmeno il prescelto Geremia, che solo una volta si permette di obiettare a questo atteggiamento divino ("Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te; ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia") ed è un passo importante (12,1), il primo dell'Antico Testamento in cui si pone la domanda fondamentale: "Perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori sono tranquilli?" Tutto il libro di Giobbe non sarà che una variazione sulla domanda complementare: perché invece i giusti soffrono? Tutto il Vangelo, volendo, non è che un tentativo di risposta. Oggi il concetto di colpa collettiva è respinto dal diritto, eppure il debito che ci schiaccia è sempre quello che accumularono i nostri genitori; l'inquinamento che ci surriscalda è la conseguenza di due secoli di scelte sventate che prima o poi ci presenteranno il conto. Di Geremia ce n'è ancora tanti in giro, tutti con qualche seguace e molti più detrattori. Anch'io devo dire li tollero sempre più a fatica: vuoi perché su questa polveriera nel frattempo ci sono invecchiato, scavandomi per quel che potevo un cantuccio confortevole; vuoi perché in loro riconosco alcuni tratti discutibili di me stesso, e non posso che diffidarne: vuoi perché per la maggior parte sono davvero cialtroni che scambiano qualsiasi congiuntura politica o economica per un segno della fine dei tempi: e nella foga di ammonirci con le loro geremiadi finiscono davvero per prestarsi alla propaganda straniera, scambiando il primo Putin che trovano per un novello Nabucodonosor.
 |
| Lei invece mi sta simpatica. |
Lo stesso Geremia non mi fa più tutta questa impressione. Ormai riconosco il personaggio, il predicatore professionista con un'agenda politica. Che possa davvero aver lanciato anatemi a tutte le nazioni senza protettori importanti, mi sembra sempre meno probabile; nel frattempo ho acquisito qualche nozione sul contesto, tutte quelle congetture che inevitabilmente erodono i monumenti dei profeti e degli eroi. Geremia compare sulla scena in uno dei momenti più ambigui e cruciali della storia di Israele: il regno di Giosia, nella seconda metà del VII secolo. È un periodo di crescita demografica per Giuda, il piccolo Stato intorno a Gerusalemme, un fenomeno che le cronache bibliche non registrano ma che gli archeologi collegano alla fine del più settentrionale regno di Israele, invaso dagli Assiri nel 720. Gli Assiri secondo la Bibbia avrebbero deportato altrove gran parte della popolazione ebraica: le famose Dieci Tribù Disperse. L'ipotesi degli storici è che invece molti profughi si siano trasferiti a sud, nel piccolo regno di Giuda, creando una tensione sociale che la Bibbia descrive come un'interminabile guerra di religione. Si contrappone una popolazione idolatra – che accanto a JHWH riconosce altri Dei tra cui una "regina del cielo" che forse è sua moglie – e una fazione monoteista di origine settentrionale che predica un monoteismo integrale, riconosce soltanto JHWH e liquida ogni altra divinità come superstizione, e durante l'infanzia del re Giosia (intronato a otto anni) prende il potere, forse con un colpo di Stato. Gli idoli vengono distrutti, i sacerdoti non ortodossi eliminati: durante i lavori per il restauro del Tempio, viene scoperto un misterioso Libro (il Deuteronomio?) che chiarisce i termini di una dimenticata alleanza del popolo ebraico con l'Unico Dio. Giosia dedica il suo regno alla riforma religiosa, ma il suo è pur sempre un piccolo regno tra le potenze del Medio Oriente. Quando muore in battaglia, durante un'incursione egiziana, il potere passa al figlio Ioacaz, che (probabilmente su pressione degli invasori) pone termine alle persecuzioni religiose: il popolo è di nuovo libero di adorare gli idoli degli invasori e magari di mescolarsi con loro.
 |
| Nabucodonosor II, che in tutti i quadri ostenta una lunga barba e in questa incisione no. |
Geremia proviene evidentemente dalla classe dirigente che ha creduto nel progetto teocratico di Giosia e ora deve farsi una ragione del suo fallimento. In questo gli intellettuali sono straordinariamente creativi, anche se alla fine tendono a raggiungere la stessa conclusione: la colpa non è mai del leader che si erano scelti, quanto del popolo che in lui non ha creduto abbastanza. Nel frattempo l'impero Assiro ha conosciuto una rapidissima decadenza e ora le due potenze egemoni sono l'Egitto e la (Neo)Babilonia di Nabucodonosor. Il regno di Giuda si trova proprio in mezzo ai due, in un passaggio obbligato strategicamente necessario per entrambi. Negli anni della predicazione di Geremia Giuda è già vassallo di Babilonia, ma la tentazione di ribellarsi e passare dalla parte degli Egizi è molto forte. C'è chi parla di trasferirsi direttamente in Egitto, e creare là un nuovo focolaio per la comunità ebraica. Geremia è assolutamente contrario, o meglio lo è il Signore che parla attraverso la sua bocca: chi si recherà in Egitto verrà spazzato via e assimilato (42,15-18), chi si ribellerà verrà massacrato. Solo chi si arrende a Babilonia potrà sperare di sopravvivere al disastro. Le accuse di essere al soldo dell'oppressore babilonese colpivano il segno: forse anche per smentirle il profeta acclude nel suo Libro l'atto di acquisto di un terreno (4,6-15), un investimento voluto ovviamente da Dio per dimostrare che ci sarà un futuro per gli ebrei in Israele, ma anche un modo per dimostrare che non intendeva rifugiarsi a Babilonia. Alla fine Geremia continua a essermi simpatico: era un uomo del suo tempo che vedeva inevitabile una rovina e si sforzava di renderla il meno disastrosa possibile. Resistere ai Babilonesi avrebbe solo complicato le cose; gli Egizi non davano nessun affidamento: meglio arrendersi, accettare la deportazione, cercare nel disastro un'opportunità. Invece di chiamare i contemporanei all'ennesima rivolta fallimentare, Geremia si guarda intorno, trova la soluzione meno peggiore e l'addita a chi ha la pazienza di dargli retta. Agli Ebrei che si arrendono, il profeta deve garantire che la resa è onorevole, e che la deportazione non è la fine della storia di Israele, anzi un nuovo inizio. E in effetti fu così, anche qui Geremia non si sbagliava. Senza più Tempio, senza più re, coi libri sacri ancora in fase di elaborazione, Geremia deve trovare una nuova dimensione per un popolo che non sa come esprimere la sua identità, e contribuisce a inventare qualcosa che stiamo usando ancora adesso: l'interiorità, il "cuore". "Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me" (9,22-23). I nuovi Israeliti non si riconosceranno dai sacrifici e dalle pratiche esteriori, ma da come meditano e riconoscono la volontà del Signore. Alla circoncisione fisica, Geremia sovrappone o contrappone una circoncisione del cuore (9,24).

Geremia lo lessi troppo presto, come la Bibbia e tutti i libri che vorrei ricordare meglio oggi. Sapete come funziona a quell'età: mi sembrava di vivere in mezzo a una folla di gente che non vedeva il disastro a cui andava incontro. Avrei voluto metterli in guardia e al contrario di Geremia ero anche convinto di avere le parole giuste: così mi misi a scrivere, ma poi rileggendo dopo un po' mi accorgevo di risultare pretenzioso e antipatico e buttavo via, e ricominciavo con un altro stile e poi buttavo via di nuovo e a furia di buttare via sono arrivato fin qui, sulla rubrica dei Santi del Post. Non mi ricordo neanche bene qual era il disastro che trovavo imminente – forse la guerra termonucleare, o il buco dell'ozono. Comunque sono qui. Di parlare di Violenza e Oppressione mi sono stancato da un pezzo, e se qualcuno ogni tanto si prendesse la briga di affrontarmi in pubblico e spezzarmi questo giogo che porto sulle spalle, io gli sarei molto grato: e volentieri me ne andrei per la mia strada.
Baricco e i suoi messia
04-04-2021, 22:48apocalittici e integrati, futurismi, religioniPermalink |
| Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? |
Il passato è tutto ciò che non esiste più, e questo è triste, perché il passato è anche l'unica cosa che possiamo davvero conoscere (quel poco che possiamo). Ogni volta che cerchiamo di immaginare il futuro, non abbiamo altra scelta che rielaborare tutto quello che sappiamo già, ovvero tutto quello che il futuro inesorabilmente supererà. Già è difficile in generale non pensare all'elefante: ma questo è uno dei casi in cui l'elefante è tutto quello che sappiamo. Anche quando ce la mettiamo tutta alla fine non facciamo che formulare cose che a ben vedere sono elefanti senza zanne, o con due proboscidi, e mentre siamo lì a domandarci se abbia un senso far passare la coda tra le orecchie, qualcosa che proprio non s'è visto fin qui, ecco che ci passa davanti una giraffa – ehi, cos'era quella? Il futuro? E chi poteva immaginarselo?
 |
| "Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!" |
Questo non significa che a furia di pensare al futuro come a una sottospecie del presente, non si possa in un qualche modo costringerlo a vestire zampe d'elefante anche quando non ne avrebbe bisogno – cioè se proprio insisti la Storia può anche ripetersi: purché in farsa. I francesi avevano questa idea che alla Monarchia avrebbe potuto seguire una Repubblica, perché lo avevano letto sui libri di Storia di Roma: ma a quel punto si poteva anche presumere che ne sarebbe seguito un Impero, e infatti così fu; avrebbe potuto chiamarsi in tanti modi, Secondo Direttorio o Nuova Monarchia, ma in un qualche modo ci si aspettava ormai un Impero. Con l'Impero poi ci si aspettava la pax romana, e invece ne seguirono più di dieci anni di guerre continentali, che a loro volta prefigurano le Guerre Mondiali, che furono due e al termine della Seconda tutti davano scontata la Terza, come si dà per scontato l'elefante: e invece venne una cosa mai vista prima, la Guerra Fredda. e poi quest'altra cosa imprevedibile fino al 1988 che forse qualcuno chiamerà Età della Globalizzazione e che potrebbe essere finita proprio con la pandemia, chi può dirlo? Napoleone era la Storia che passava a cavallo, l'Ever Given potrebbe essere la Storia che si impantana nel Canale di Suez. E magari invece no, magari tra sei mesi la pandemia sarà solo un brutto ricordo da gettarsi alle spalle e il traffico di merci circonderà il mondo in una morsa più pulsante che mai. Non ne ho la minima idea, non faccio che proiettare elefanti, quando arriverà una giraffa è già tanto se me ne accorgerò. Per fortuna di mestiere non vendo giraffe.
Baricco, viceversa.
Baricco nel suo ultimo intervento l'ha messo nero su bianco: lui è un messianico, e questo è il secondo motivo per cui mi metto a scrivere di lui il giorno di Pasqua (il primo motivo è che non ho voglia di lavorare).
Sempre questo istinto messianico ad aspettare il salvatore. A cercare una stella cometa nel cielo per capire dove sta nascendo. Principio speranza.
E vabbe'. Mi è venuto in mente un pezzo di qualche tempo fa, in cui contrapponevo gli apocalittici ai messianici. Ecco: non potevo chiedere di meglio, per illustrare la differenza, di un esempio come il suo. L'apocalittico vive nel timore e nel tremore che il mondo possa finire in qualsiasi momento e per colpa di chiunque, lui compreso. È l'erede di centinaia di generazioni di apocalittici, tutti sconfessati dai fatti, tutti a posteriori descrivibili come mitomani allucinati: e ciononostante come tutti quelli che lo hanno anticipato, l'apocalittico del 2021 è perfettamente credibile nel 2021; solo nel 2031 lo liquiderete come ridicolo. Ma nel frattempo dovete ammettere che ha i suoi argomenti, e che nessun apocalittico del passato li ha avuti tanto buoni come i suoi. Mai come oggi l'umanità risulta appesa a un filo, o magari a due o trecento, ma comunque sono fili e sono sottili. C'è troppa anidride carbonica nell'aria. Gli oceani si innalzeranno. Dal permafrost che si congela dopo milioni di anni resusciteranno virus e batteri che non conosciamo, forse sono già risorti. Nel frattempo cominciamo a crescere, siamo otto miliardi e non è chiaro di cosa ci nutriremo tra vent'anni; a dire il vero non è nemmeno chiaro dove ci procureremo l'acqua da bere: quanto al petrolio da bruciare, è escluso, non si può fare, chi lo farà dovrà essere fermato con le buone o le cattive e a tal proposito nelle ultime due velocissime ere abbiamo accumulato talmente tante armi che l'opzione di un'estinzione rapida e violenta continua a essere sul tavolo. Quando si parla di futuro, questi sono i dettagli che ha presente l'apocalittico; questi sono i pezzi del suo elefante. Baricco invece è contrariato perché pagare una bolletta con lo smartphone è ancora un po' difficile.
 |
| Seriously? |
Baricco pensa che nel futuro metteremo da parte la razionalità, e coerentemente non si preoccupa di spiegarci perché di tante cose del XX secolo proprio la razionalità dovrebbe cedere il passo (e proprio mentre sull'affare con cui scrive gli algoritmi gli correggono gli errori di battitura). Glielo dice l'istinto. La mia ipotesi è che Baricco, immaginandosi alla svolta di un secolo, non riesca a non immaginare la svolta che conosce meglio in quanto uomo di cultura e musicologo. E in effetti, se ci avviciniamo meglio al suo elefante, ci rendiamo conto che assomiglia più a Beethoven che al K-pop.
Baricco ci chiede di abbandonare il Novecento, e senza accorgersene ne parla come fosse il Settecento razionalista. Baricco ci vorrebbe finalmente nel XXI secolo ma non può impedire di immaginarlo come un update dell'Ottocento romantico. Si potrebbe veramente prendere un po' di frasi, mescolarle a un Chateaubriand o a uno Schiller, e giocare a riconoscere chi ha scritto cosa. I messianici sono così, prenderli o lasciarli: hanno deciso di aspettare qualcosa, il che implica che qualcosa debba ancora arrivare, e se anche loro hanno un timore, è quello di non riconoscerlo quando arriverà. Gli ebrei lo aspettano da millenni; i cristiani in realtà lo hanno trovato, salvo che se n'è andato via subito, lasciando detto che torna: e di guardarsi nel frattempo dalle imitazioni. A quel punto apriti cielo: da duemila anni non facciamo che guardarci in cagnesco, chi sarà il vero messia? Potrebbe essere chiunque, compreso tu che leggi, ma è più facile che tu sia l'ennesimo falso messia, maledetto impostore. Sarebbe facile smontare tutte le previsioni di Baricco e mostrargli come tutto quello che lui s'immagina nell'elefante del futuro si sia già realizzato, a volte addirittura due secoli fa; senonché smontare il messia ai messianici è come rubare caramelle ai bambini: un gesto non solo vigliacco, ma che non regala all'adulto che una misera soddisfazione – alla nostra età che ce ne facciamo, delle vostre caramelle?
 |
| Chaque age a les prophetes qu'elle mérite |
Baricco in pandemia lamenta "l’autorità razionale di un preside ottuso" – e i presidi nel frattempo si stanno facendo in quattro per recepire direttive ministeriali, regionali, collegiali e genitoriali; "la cieca rigidità dei programmi ministeriali", che sono stati aboliti più di trent'anni fa e da allora popolano i sogni degli editorialisti, come quei genitori crudeli che non abbiamo avuto e segretamente rimpiangiamo. Baricco prepara nel deserto la strada a una miracolosa Start Up "destinata a smantellare l’assurda complessità del pagamento delle multe", si immagina tutto un complesso burocratico-industriale che fatalmente si opporrà alla messianica Start Up, e conoscendo la fatica di chi si avvicina allo Spid posso capirlo, ma proprio ieri ho pagato una multa e ci ho messo cinque o sei clic – certo, da un computer: con l'Iphone dev'essere ancora un supplizio.
Baricco certi messia li avrebbe anche individuati, ma non possono essere quelli veri, e anche qui niente di nuovo. Tutte le volte che la Storia è passata a cavallo sui due cigli della strada c'era un sacco di gente che scuoteva la testa: non è il cavallo giusto, non ha la criniera che ci aspettavamo, non doveva passare di qua ma venti leghe più a nord, ecc. Bezos Musk o Zuckerberg hanno veramente cambiato la nostra vita, ma non possono essere i veri messia per una serie di motivi che Baricco si fa venire in mente con facilità: ad esempio, sono "maschi, americani, bianchi", proprio mentre la crescita della popolazione rende i wasp una minoranza sempre più marginale. Inoltre sono "ingegneri", proprio nel momento in cui Baricco ha dichiarato la razionalità come irredimibilmente novecentesca. Sono anche degli schiavisti, aggiungo io. Almeno Bezos tende a comportarsi come tale: ma questo non è tra i motivi espliciti per cui Baricco lo rigetta come falso messia. Non è mica il primo influencer che passa, Baricco; non è per abbassarsi a fare il profeta di uno Zuckerberg che si è inoltrato nel deserto. Ha bisogno di qualcosa di più nuovo, di più degno del suo apostolato, qualcosa di davvero interessante, dirompente – ma cosa?
Lo chiama "intelligenza" – un nome come un altro. "Respiro del mondo": ci stiamo avvicinando. In un altro secolo lo chiamavano Spirito Santo. Sarà qualcosa di fighissimo, che ci risolverà l'esistenza: in un istante conosceremo tutte le lingue degli uomini e degli angeli, e non vi sarà più confine né dolore. In attesa della Nuova Pentecoste però il commercio mondiale è incastrato in una rete antiquata che si può saturare per un nonnulla: basta anche solo che una super-chiatta sbagli manovra in un canale inaugurato nel 1869. I virus ci minacciano, la Razionalità trova vaccini a tempo record ma non riesce a uniformarne la distribuzione. Nell'emergenza, ogni Paese va per i fatti suoi, e chi più aveva creduto sia all'internazionalismo che alle regole del mercato (la UE) ci fa la figura del fesso che ottiene le condizioni peggiori. L'apocalittico passa le giornate a domandarsi: cosa sarà di noi, alla prossima ondata, alla prossima crisi? C'è un rincaro delle materie prime alle porte, l'Iphone sul quale Baricco si aspetta di pagare le multe potrebbe non essere più rimpiazzato a lungo da un prodotto più potente. Il commercio mondiale è ancora sostenibile, o non dovremmo piuttosto riorganizzare la produzione ripartendo il mondo in quattro cinque blocchi autosufficienti? Ma anche una volta che si fossero costituiti questi blocchi, come impedire che lo scontro per le materie prime non degeneri in conflitto aperto, come distinguere questo scenario da quello previsto da Orwell? E tra questi interrogativi, il più penoso di tutti: come facciamo a spiegare agli occidentali che anche nel migliore degli scenari la festa è finita, che il benessere non sarà più un diritto di cittadinanza? Che un modello totalitario come la Cina Popolare per ora sembra rispondere alla crisi con più consapevolezza e riflessi pronti delle tronfie democrazie atlantiche?
Non importa quanti incubi lo perseguitino sin da bambino; l'apocalittico non conosce assuefazione, ne trova sempre uno più grave per cui preoccuparsi. Quando l'angoscia risulta intollerabile, l'unica consolazione a guardarsi indietro, ricordare che non è che l'ultimo di una teoria di profeti di sventure in gran parte mitomani, gente che ogni vent'anni se ne esce con la data della Fine e non ci azzecca mai. Ce ne sono stati tanti come me (pensa l'apocalittico) e la Storia li ha sbugiardati tutti: perché dovrei essere il primo che ci azzecca sul serio? Chi mi credo di essere? Non sto che fabbricando un brutto sogno, con i pezzi dei brutti sogni dei miei antenati: Orwell, e Huxley, e Huntington, e Marx, e compagnia? Finché una mattina non vedrò passare qualcosa di mai visto, così incredibile che forse nemmeno lo riconoscerò, e sarà il futuro: sarà assurdo e insieme aggraziato e naturale come una giraffa, sarà incomprensibile ma magari molto migliore di tutto quello che ho sognato, perché sapevo solo sognare disastri. Potrebbe anche essere bello – non c'è nessuna necessità che lo sia, ma perché non potrebbe?
Se invece passa proprio Baricco, un po' m'incazzo (sempre meglio dell'estinzione di massa: e tuttavia).
Il Covid alla fine del mondo (pagani, apocalittici e messianici).
17-11-2020, 22:45apocalittici e integrati, epidemia 2020, religioniPermalinkNon ci sono soltanto pagani e apocalittici. C'è un'altra famiglia di iceberg, più difficile da distinguere: è quella con cui me la prendo più spesso, come succede sempre tra gente che in teoria era compagna di strada. A differenza dei Pagani, essi non negano la possibilità di un'Apocalisse; a differenza degli apocalittici semplici come me, a volte persino la desiderano, per le potenzialità che scatenerebbe. Come definire un gruppo di persone unite dalla credenza irrazionale che da un'Apocalisse potrebbero venire cose buone? Non ho quasi scelta: devo definirli messianici. Magari non aspettano tutti lo stesso messia: per alcuni è un'utopia anarcosocialista, per altri è la democrazia partecipativa, per altri ancora un totalitarismo alla Putin; alcuni non sanno nemmeno che è un messia che stanno aspettando, ma lo aspettano lo stesso. Queste persone hanno nei confronti del Covid19 le difficoltà che avevo io all'inizio: non lo trovano abbastanza apocalittico. Non fa nulla di quello che dovrebbe fare un Armageddon serio. Non capovolge la piramide del potere, anzi la puntella; non getta i lavoratori nelle piazze, anzi li blinda in casa; non punisce i superbi per la loro avidità, anzi, stanno già speculando sui rialzi della Pfizer. Non è un'Apocalisse, è un bidone, un falso messia da rigettare. Queste le premesse irrazionali; da lì si innerva la razionalità, puntando il dito sugli abusi del potere, sul ruolo proditorio del capitale, sulla funzione di paravento assunta dai media, e devo dire che sono tutte analisi interessanti e fino a un certo punto condivisibili anche da me – perlomeno finché si rimane nella sfera razionale. Ma è impossibile: non possiamo nemmeno accostarci, senza che sott'acqua i nostri iceberg cozzino. Spero di essermi spiegato, almeno un poco.
Il trapassato non trapasserà
10-04-2016, 21:42apocalittici e integrati, contro la lingua italianaPermalinkImmagino che un pezzo del genere esca almeno una volta alla settimana, su almeno un quotidiano. Giornalisti e scrittori si danno il turno. Gli odori che non torneranno, le mezze stagioni che scompaiono, ne parlava già Leopardi nello Zibaldone (non scherzo, ne parlava davvero citando a sua volta un autore del Seicento, per dire quanto sia topico il problema delle mezze stagioni nell'elaborazione degli intellettuali italiani).
Mi metto a parlarne perché, oltre alle solite foto ingiallite e ai soliti dischi che, siamo onesti, se non eri un maniaco della pulizia dopo un po' li avevi tutti segnati e impolverati e suonavano di merda, lo scrittore ha inserito tra le belle cianfrusaglie del tempo che fu anche un tempo verbale. Oddio, neanche questa sarebbe una novità. Il presente congiuntivo era dato moribondo dalla Stampa già nel maggio del 1968 - e come altre cose dichiarate morte in quel periodo, gode ancora di buona salute. Anche il passato remoto, con tutte quelle radici irregolari che lo rendono tanto ostico, più in Valpadana che altrove, in un qualche modo l'ha scampata. No: forse la notizia è qui. La scorsa settimana Roberto Cotroneo, sentendosi probabilmente obbligato in quanto scrittore italiano a lamentarsi del tempo che passa, ha deciso di piangere le sorti del trapassato remoto.
 |
| Lui invece sta benissimo e vi saluta. |
Pare infatti che non usiamo più il trapassato remoto, e che ciò sia un male, perché... perché ci aiutava a depositare i ricordi in cantina, dove prendevano quel necessario odore di muffa che oggi la civiltà digitale non consente più, non capisce più. "Il trapassato remoto si usa per azioni concluse che non hanno alcuna rilevanza con il presente e con l’attualità. Oggi invece tutto ha rilevanza con l’attualità, e nulla si conclude". Sarà. Dando per scontata l'apocalisse digitale, mi resta la curiosità di sapere se è vero. C'è sul serio una flessione nell'uso del trapassato remoto? Esistono studi al riguardo? Se qualcuno ne sa qualcosa, lo prego, mi contatti. Nel frattempo non posso evitare di chiedermelo: se anche sparisse del tutto, il trapassato remoto, sarebbe un male? Preso di per sé, è un tempo verbale molto brutto. Diciamo che mette insieme le cose meno gradevoli degli altri tempi passati: il remoto è asciutto ("fu!") ma irregolarissimo, la croce di ogni corso di italiano per stranieri. I passati composti, per contro, sono belli regolari, ma lunghi, noiosi ("aveva fatto"). Ecco, il trap remoto, essendo un composto del passato remoto, è irregolare come quest'ultimo, e noioso come ogni verbo composto ("ebbe fatto"). Forse se scompare c'è un motivo. Ma sul serio scompare?
Non è inverosimile. Non perché sia brutto. Magari si potesse fare senza le cose brutte. Metti il trapassato prossimo. Non è che sia molto più bello del trap remoto: ebbene, va alla grande. Nei temi dei miei ragazzi noto sempre più questa cosa. Quando scrivono al passato si imbrogliano sempre. Vorrebbero usare il passato remoto, che è così svelto ed espressivo, ma hanno sempre paura di sbagliarlo. Allora saltano al presente, con un effetto cinematografico che nove volte su dieci provoca l'apparizione di vigorosi segni rossi sul foglio "Il pirata mi chiamò e mi dice di far presto"), oppure... al trap prossimo "Il pirata mi chiamò e mi aveva detto di far presto"). Che è persino più orribile. Ma l'idea è più o meno quella: mi serve un passato veramente passato, un passato che mi faccia sentire che il tempo è davvero... passato. La muffa, la polvere, quel tipo di cose. Anche i ragazzini sentono di averne bisogno.
Il trap remoto però è accessibile solo a chi sa già coniugare il passato remoto. Non solo, ma di tutti i passati dell'indicativo è quello che può essere impiegato in meno situazioni: solo in una proposizione subordinata temporale. Come tutti i trapassati, il trap remoto è qualcosa di più di un passato: serve a creare un minuscolo flashback in una frase che è già al passato. Se per esempio sto scrivendo "andai al supermercato", per aggiungere a questa frase un'altra frase (subordinata) situata in un momento anteriore, posso usare il trap remoto: "dopo che ebbi ricevuto la tua lista della spesa". In questo senso si dice che il trap remoto, come il trap prossimo, esprime l'anteriorità, ovvero il concetto di passato nel passato. Ma nella frase ci dev'essere già una frase al passato, perché io possa andare ancora più indietro con una subordinata al trapassato.
Ecco: uno dei motivi per cui il trap remoto potrebbe scomparire è che tendiamo a subordinare sempre meno. Questa sì, è una tendenza generale che si può riscontrare nei quotidiani e soprattutto nei libri. Come tutte le lingue, l'italiano scritto è diventato più cinematografico: frasi brevi e incalzanti, separate tra loro. I nessi temporali, o di causa-effetto, vengono lasciati all'interpretazione del lettore. Là dove un autore di primo Novecento avrebbe scritto, ad esempio, "la marchesa uscì solo alle cinque, dopo che ebbe ricevuto il biglietto", il suo collega dei primi Duemila preferirà: "la marchesa ricevette il biglietto verso le cinque. Subito dopo uscì". Nel primo caso abbiamo un'organizzazione sintattica, ricalcata sulle forme del latino; nel secondo abbiamo il montaggio cinematografico di due scene. Addirittura abbiamo sempre più esempi di narrazione al presente ("La marchesa riceve il biglietto ed esce"). È chiaro che un'evoluzione di questo tipo condanna il trap remoto, ma anche tante altre cose più interessanti.
È curioso invece che Cotroneo accusi velatamente la rivoluzione digitale di averci tolto il (dubbio) piacere del trap remoto: la tendenza a semplificare e abolire la sintassi è molto più antica. È già impugnata da scrittori e artisti nel Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912), l'anno di massima espansione della nascente industria cinematografica in Italia. Una coincidenza? Forse se tendiamo ad abolire i trapassati, e la sintassi in genere, è perché anche i nostri ricordi sono diventati sempre più cinematografici. Non li organizziamo più in un discorso orale o scritto, ma li riviviamo davanti ai nostri occhi come un film (È questa tra l'altro la speranza che porta Zeno Cosini a frequentare il suo analista: strappare al passato non un senso ma delle "immagini": "Vedere la mia infanzia!").
Un altra peculiarità del trap remoto è il suo aspetto (lo so, è così interessante che ne volete ancora, ebbene, prosegue sul Post!)
Ora e sempre contro l'Apocalisse (e chi la vende)
21-02-2016, 14:05apocalittici e integrati, coccodrilli, EcoPermalink |
| Famiglia Cristiana |
Se vi è capitato di frequentare un tipico erudito, e di notare come passi il tempo a (1) parlare delle cose che sa; (2) spiegare come le cose che non sa non siano importanti, e senz'altro indegne del suo prezioso tempo, ecco, ci terrei a ricordare che Umberto Eco era l'esatto contrario. Era curioso: non di tutto, ma di tantissime cose; ed era sempre disposto a impararne di nuove, persino dal primo studente che incontrava sul suo cammino. Troverete nei suoi scritti e discorsi confessioni disarmanti: per esempio ieri sera mi sono imbattuto nella sbobinatura di una conferenza sull'Esperanto in cui spiegava di averne studiato la grammatica soltanto pochi mesi prima, mentre lavorava alla Ricerca di una lingua perfetta nella cultura europea. È solo un dettaglio, ma pensateci un attimo: erano i primi anni '90. Eco era ai vertici della sua popolarità come scrittore e del suo prestigio intellettuale. Avrebbe potuto ricucinare le stesse cose che scriveva dieci o vent'anni prima, e invece si metteva a studiare la grammatica di una lingua nuova, come un ginnasiale - e pochi mesi dopo ci faceva un corso monografico e ci pubblicava un libro. Potremmo scambiarlo per dilettantismo d'altri tempi, quando è semplicemente quel tipo di spericolata apertura che ti chiede il mestiere di semiologo: se il mondo è una crittografia, ci saranno pure cose che sono più interessanti di altre - così ad esempio Rita Pavone a occhio non vale Gérard de Nerval - ma non puoi saperlo prima di averle decifrate (continua sul Post).
Uomini e talpe
08-04-2011, 20:08apocalittici e integrati, come diventare leghisti, migrantiPermalink- Io credo che chiunque abbia gli occhi per vedere, e non per piagnucolare, possa valutare da solo che uomini sono questi Bossi, questi Maroni, che di fronte a un'emergenza umanitaria gridano foera di ball, fanno portare cucine da campo a Lampedusa ma non le montano, aspettano che una folla affamata distrugga tutto e poi portano spazzini e telecamere per mostrare al loro elettorato che siamo alle invasioni barbariche; lasciano una ventina di marinai a pattugliare un enorme braccio di mare e poi stringono le spalle di fronte a una tragedia evitabile; tanto in mezzo c'è sempre una Malta o una Francia su cui puntare il dito, come lo punta sul compagno il bambino sorpreso dalla maestra. Non sono criminali, questi bambini che sventolando fazzoletti verdi sono arrivati a responsabilità di governo e ora giocano con la vita dei loro simili? Fino a che punto il proprio tornaconto elettorale li giustifica di fronte all'orrore, quanto costa esattamente in vite umane vincere le elezioni in Brianza? Chiunque ha occhi per vedere e non per piagnucolare può vedere quanto siano criminali, e quanto assassina sia la loro negligenza.
Eppure odiarli è difficile. Sono un po' troppo banali, questi amministratori locali del male; non fanno che incarnare i nostri difetti, trarli alle estreme conseguenze. La paura per lo straniero non l'hanno inventata loro; loro non hanno fatto che aprirci la loro piccola impresa, la loro fabbrichetta, trent'anni fa. Col senno del poi fu un ottimo investimento: da allora il sud del mondo ha quasi raddoppiato le bocche da sfamare, mentre il nord alzava le barricate; il nodo prima o poi doveva venire al pettine. Chiunque può calcolare quanto abbiamo perso in umanità, negli ultimi vent'anni di sbarchi: quanto rapidamente si è spenta quella solidarietà genuina che mostravamo per i primi albanesi e i cossovari, appena abbiamo capito che non erano piccoli fuochi, ma le prime scintille di un incendio mondiale. I nostri governanti non fanno che interpretare al meglio quello che siamo diventati: animali tutto sommato mansueti che quando li si preme ai confini hanno ancora qualche energia per mostrare i denti.
Ma gli intellettuali? Non devono mica farsi eleggere. Nessuno pretende che si facciano interpreti dei nostri istinti più bassi. Anzi, dovrebbero mirare un po' più in alto per definizione; nell'eclissi della nostra coscienza, conservare per noi il ricordo della luce, e ricordarci sommessamente che potremmo essere migliori di così, potremmo essere uomini e non bestie. E invece guarda che bel servizio ci rende Ceronetti, col suo temino xenofobo che nessuno gli aveva chiesto, ma che molte bestie apprezzeranno. “Non ho prove provabili”, scrive, “ma ho il senso del pericolo, in comune con tutti gli animali”. Ed è tutto quello che gli serve per tenere la sua concione: l'istinto animale del pericolo. La sua “pulce nell'orecchio” non è un dato preciso, né un'informazione verificabile, nulla. Ceronetti ha il senso di ragno di Peter Parker, sente un complotto islamico dietro le spalle e ci vuole tenere informati, grazie Ceronetti, ma avrebbe potuto dircelo qualsiasi boccalone al bar. Sì, però vuoi mettere con uno che al bar ti cita Kafka e il cavallo di Troia? Ed eccolo qui, il più bell'argomento contro la cultura: se dai da leggere Kafka a una capra, ne brucherà le pagine e resterà capra; se lo dai a un scimpanzè rischi che te lo tiri in testa: lo hai dato a Ceronetti, guarda cosa ne fa.
La questione israeliana. Ma io qui credo che ci sia un refuso. Avranno tutti copiato e incollato male, andiamo, non è possibile che un pregiato scrittore lasci sulle colonne di un quotidiano questa frase, nel 2011: “Se Israele accogliesse tre o quattromila palestinesi, Gerusalemme, il supremo esito del 1967, sarebbe subito, com’è già in parte, casa loro”. Si possono dire cose molto brutte su Israele, ma ci vive già più di un milione di arabi con diritto di cittadinanza. Voglio dire che lo sanno anche le talpe. O non lo sanno? E di cosa hanno discusso, per tutti questi anni, le talpe, sul giornale?
"In qualità di profughi da guerre, lo scenario di guerra è da trovare. Le folle di veri profughi le conosciamo: prevalgono le donne e i bambini, ci sono immagini strazianti di vecchi che si trascinano… Qui l’anomalia è sbadigliante: di vecchi neanche l’ombra, e di aneliti a trovare lavoro non ce n’è spreco".
Il Novecento è davvero la nuova Bibbia. Messo di fronte a un fatto nuovo, l'intellettuale cosa fa? Va a controllare se rientra nella casistica dei Sacri testi. C'è una folla di profughi? Andiamo a sfogliare il Libro dei Profughi del Novecento, dunque... ecco, ci sono soprattutto donne, bambini, vecchi che si trascinano. Invece nelle foto a colori del giornale, qui, sono baldi giovanotti, e allora fermi tutti: l'intellettuale ha scoperto un'impostura, un complotto. “ Il mio non è che un sospetto fondato”. Fondato sul suo senso di ragno, che gli anni hanno reso acutissimo.
Per fortuna che noi animali europei abbiamo ancora un forte istinto, lo si vede dalle bandiere ai balconi. “Un senso di inconscio risveglio dell’istinto difensivo mi pare di leggerlo in questa perdurante spontanea esposizione del tricolore. C’è come un grido silenzioso dell’anima profonda. Queste bandiere non celebrano un passato, ma sono talpa che non vuole diventare casa loro e grida aiuto. Ma a chi, se nessuno comprende?” Meno male che Ceronetti comprende. Lui è collegato con l'anima profonda, ne sa interpretare i gridi silenziosi, per esempio quell'arcano, intraducibile “Foera di ball”, finalmente trova in lui il fine esegeta, il traduttore. Abbiamo bisogno di più gente come lui, che metta in belle parole i nostri istinti, che suoni il suo tamburino istoriato con fregi Novecento mentre noi scaviamo i fossati e alziamo i recinti.
“Difficile, più che mai, capire; ma intelligere è essenziale. E una volta compreso prendere decisioni giuste è difficilissimo. Volerle giuste e umane, e insieme battere un nemico oscuro, un’armata disarmata, che ha per unica micidiale arma il numero, è una canzone di gesta.”
Parole desuete, parole buffe, il consueto bric-à-brac letterario che ha sempre il suo mercato, per dire cosa? Niente, è destino di ogni temino poco ispirato risolversi in tautologia. Ceronetti aveva rivendicato nella prima riga il suo istinto del pericolo, “comune agli animali”; nell'ultima riga si lascia sfuggire che soluzioni umane al problema non ce ne sono. Insomma l'umanità è un lusso, grazie Ceronetti, ma a quel punto perché Kafka, perché Omero, perché le canzoni di gesta, perché pagarti un vitalizio? Non sarebbero soldi meglio spesi in barricate, filo spinato, alta tensione?
Ma forse no. Anche quando saremo lupi - e il giorno non è così lontano - avremo sempre bisogno di un lupo anziano e un po' più ispirato che ululi alla luna. Com'è da millenni, e la luna resta luna. E i cani restano cani. I più bravi, i più brillanti, se gli tiri Kafka te lo riportano.
Il Paese che ha bisogno di Popstar
24-03-2011, 00:05apocalittici e integrati, culturaPermalinkIl blog è morto 4567
14-03-2011, 16:13apocalittici e integrati, blog, contro la lingua italiana, ho una teoria, internetPermalinkUn certo grado di autoreferenzialità è inevitabile. Ma diventa insostenibile soltanto quando si tratta di blog. Se si invitano dieci scrittori a una tavola rotonda, è ovvio attendersi che discutano di letteratura. Se chiami dieci economisti, di economia. Ma se dieci blogger intorno a un tavolo si ritrovano a parlare di blog, devono per forza chiedere scusa per l'autoreferenzialità. In realtà tutta questa spinta ad annoiare i lettori raccontando i fatti nostri, ieri, non si sentiva. Si è discusso dello spazio che condividiamo. Non è mai stato uno spazio molto popolato e importante, quello dei blog italiani: sei o sette anni fa la stampa provò anche a venderci come la nuova rivoluzione internettiana, ma la verità è che non siamo mai stati moltissimi e non siamo mai stati eccezionali. Però secondo me l'autoreferenzialità non deve portarci all'autodenigrazione. Qualcosa di buono lo abbiamo fatto: abbiamo portato qualche argomento, sollevato qualche questione, e in generale lo strumento che abbiamo scoperto ormai dieci anni fa continua a essere molto valido. Per fare un esempio: in queste ore il reportage in lingua italiana più interessante dal Giappone si legge su un blog, Pesceriso. Ovviamente l'autore parla delle cose che capitano intorno a lui, che vive a Tokio. È autoreferenziale? Avercene.
È vero che i blog – e la Rete in generale – ci mettono in una condizione ideale per esprimere un'aggressività che nella vita 'reale' siamo costretti a contenere. Per molti anni internet è stato un luogo dove non mostravamo i nostri volti, proprio come non li mostriamo mentre guidiamo nel traffico cittadino: l'aggressività dell'internauta in questo senso non è molto diversa da quella dell'automobilista, è un 'calcare i toni' che denuncia l'ansia di non riuscire a farsi capire. Però il blog è uno strumento complesso, non funziona soltanto con la rabbia o con l'indignazione. Prima o poi l'energia che si manifesta in modo aggressivo si deve articolare in qualcosa di più articolato: lo stesso Grillo dopo o giorni del Vaffanculo ha dovuto mostrarsi propositivo, era il suo stesso pubblico che glielo chiedeva. Ma Grillo è un caso molto particolare, preferisco citare il mio: ero una persona molto più aggressiva e insicura quando ho cominciato a scrivere. Sono abbastanza contento di avere trasformato tante orribili incazzature in frasi e in ragionamenti, che altre persone hanno condiviso. Può anche darsi che se fossi rimasto senza questo 'sfogatoio' a un certo punto sarei esploso e avrei fatto la rivoluzione. Io però sono uno di quelli che crede alle rivoluzioni lente, graduali, che passano per la progressiva acquisizione di una consapevolezza. La gente che scoppia all'improvviso mi ricorda i kamikaze di Hamas, mi auguro di poterne farne a meno.
Sì, infatti ci avevano già dati per morti nel 2004, nel 2005, nel 2007... la prova della nostra decadenza è che nessuno fa più un bel titolo “il blog è morto”, non facciamo più notizia neanche come zombie. Senz'altro non è più lo strumento preferito dai teenager, ammesso che lo sia stato: però fino a tre-quattro anni fa, quando la principale piattaforma di aggregazione giovanile era MSN, era normale sentire un quindicenne dire “ho un blog”, “questa la metto sul mio blog”. Poi c'è stato youtube, poi myspace, adesso facebook, e gli adolescenti sono stati tra i più rapidi a cambiare mezzo. Senza dubbio lo strumento testuale è il più difficile da padroneggiare per loro; si fa molto prima a taggare una foto o caricare un video. Non credo sia il caso di farne un dramma, c'è un tempo per comunicare con le immagini e un tempo per sperimentare la comunicazione testuale (e sui blog si sta molto meglio da quando pettegolezzi barzellette e chiacchiere varie sono finite su Facebook). Detto questo, aveva ragione ieri chi si lamentava che fossimo le solite facce stanche, i soliti capelli grigi. Dove sono i blogger giovani? Ecco, appunto: dove sono? Io di blogger bravi ventenni non ne conosco: sarà un mio limite, ma se penso alle cose che scrivevo a vent'anni... fortuna che non c'erano ancora i blog.
Più che unità d'Italia, preferirei parlare di unità di italiani, che su internet sono una tribù compatta, forse un po' troppo impermeabile, tenuta assieme dal collante della lingua italiana. È chiaro che è una lingua banalizzata e standard, credo che entro certi limiti sia il prezzo da pagare. Però è una base su cui ripartire con quell'opera di rialfabetizzazione che secondo me è una delle componenti fondamentali di quella famosa rivoluzione di cui si parlava ieri. Ora che abbiamo un vocabolario comune, possiamo riallargarlo pian piano. I blog possono avere il loro ruolo in questo processo: possono riscoprire parole e concetti e rilanciarli in modo virale. In realtà il successo di una iniziativa come quella di ieri (magari tutti i problemi tecnici avete partecipato in tantissimi), dimostra che le persone hanno voglia di scriversi, leggersi, confrontarsi: i blog servono a questo. E a sentirci dire che siamo autoreferenziali. Certo: parliamo delle cose che ci interessano, che ci succedono, che conosciamo. Di cos'altro dovremmo parlare? http://leonardo.blogspot.com
Il nuovo Baudo (è meglio del vecchio)
10-03-2011, 17:13apocalittici e integrati, cultura, la sinistra perde anche per questo motivo, nazionalpopPermalinkL’intellettuale moderno non è più da tempo la cinghia di trasmissione tra il partito e le masse. All’egemonia culturale della sinistra è subentrata, silenziosa ma devastante, una nuova egemonia “sottoculturale”, per usare un’espressione di Massimiliano Panarari, che ha soppiantato la prima, inoculando nella società il pericoloso e pandemico germe del populismo mediatico.
Sedici anni di dominio berlusconiano hanno impresso un segno indelebile nel carattere nazionale. Per uscire dalle strettoie della sottocultura berlusconicentrica e per sfuggire al gorgo mefitico dell’autoreferenzialità, l’intellettuale ha ceduto di schianto. Succube da decenni di dibattiti autopoietici e di soporiferi cineclub, ormai ebbro e nauseato dalla propria presunta superiorità morale, da tempo degradata in un indifendibile moralismo da casta protetta, la sinistra culturale ha rotto le righe e, muovendosi in ordine sparso, si è buttata nello stesso circuito di populismo della destra, innervato da robuste iniezioni di moderni steroidi catodici. Quel che rimane dell’industria culturale in mano alla sinistra scimmiotta il baudesco nazionalpopolare, utilizzando le antiche corde dell’emozione, del sentimento, dell’anima, dell’antirazionalismo, dell’antimodernismo e della cialtroneria, che da sempre costituiscono il nerbo della melodrammatica e furbesca indole italica. Così nasce e prospera Giovanni Allevi...
Alcune obiezioni:
1. B e r l u s c o n i h a v i n t o. Ci ha inoculato. Abbiamo ceduto di schianto e adesso ci ritroviamo Allevi, mentre prima ascoltavamo... ascoltavamo... boh, Benedetti Michelangeli? Trocino, che pure identifica con molta chiarezza quali sono i contenuti deteriori delle 'popstar' (sentimentalismo, antirazionalismo, primitivismo, eccetera), e altrove se la prende esplicitamente con i “venditori di apocalisse”, ecco, Trocino non è del tutto immune dal sentimento apocalittico. Addirittura nella sua versione più svenduta, l'antiberlusconismo. Per immaginare che Berlusconi ci abbia lasciato un segno indelebile, dobbiamo postulare un'età dell'innocenza in cui non eravamo berlusconiani, non avevamo ancora colto la mela del biscione e quindi fruivamo di una cultura vera, senza popstar. Ma è mai esistita questa età dell'oro in cui invece di Allevi ascoltavamo Benedetti Michelangeli, mentre sfogliavamo La dialettica dell'Illuminismo invece di Camilleri? Lo chiedo a voi, io non me la ricordo, sarà che sono giovane?
 Trocino stesso indica come prima manifestazione di popstar culturali la tenzone post 11 settembre tra la Fallaci e Terzani sulle pagine del Corriere. Ecco, per esempio, la Fallaci. Senz'altro una popstar quando scriveva La Rabbia e l'Orgoglio (la cui estrema appendice si chiama, guardacaso, Apocalisse). Ma la Fallaci degli anni Settanta? Qualla delle super-mega-interviste coi protagonisti del Novecento? La Fallaci di Un uomo o di Lettere a un bambino? Non aveva già il piglio, il carisma e il pubblico di una popstar? E... Pasolini? Trocino si ritrova a citarlo spesso, come padre putativo di un certo sentimento antimoderno che serpeggia tra le nuove popstar. Pasolini è un autore contorto e aggrovigliato sulla sua stessa ideologia, ma pensiamolo semplicemente nel ruolo che interpretava (che aveva in un qualche modo acconsentito a interpretare) nel dibattito culturale degli anni '70; pensiamo alle Lettere Corsare: non era una popstar – anzi, meglio, una rockstar – anche lui, quando scriveva “io so” o “vi odio cari studenti”? E la Morante del Mondo salvato dai ragazzini? E Don Milani, non quello asperrimo delle Esperienze pastorali, ma quello edulcorato della vulgata veltroniana, quello che è un eroe perché non boccia gli studenti poveri? E Dario Fo? E Indro Montanelli quando faceva lo storico? Ed Enzo Biagi quando diventava un marchio di fabbrica (garanzia di medietà) da appiccicare su qualsiasi prodotto industriale, compresi i fumetti? Tutto questo succedeva quando Berlusconi faceva al massimo il palazzinaro: non l'ha inventato lui il midcult. In seguito non mi sembra che abbia aggiunto molto a una formula già rodata. Ne ha semplicemente approfittato, come qualsiasi editore (Feltrinelli non lo ha fatto? E Adelphi?)
Trocino stesso indica come prima manifestazione di popstar culturali la tenzone post 11 settembre tra la Fallaci e Terzani sulle pagine del Corriere. Ecco, per esempio, la Fallaci. Senz'altro una popstar quando scriveva La Rabbia e l'Orgoglio (la cui estrema appendice si chiama, guardacaso, Apocalisse). Ma la Fallaci degli anni Settanta? Qualla delle super-mega-interviste coi protagonisti del Novecento? La Fallaci di Un uomo o di Lettere a un bambino? Non aveva già il piglio, il carisma e il pubblico di una popstar? E... Pasolini? Trocino si ritrova a citarlo spesso, come padre putativo di un certo sentimento antimoderno che serpeggia tra le nuove popstar. Pasolini è un autore contorto e aggrovigliato sulla sua stessa ideologia, ma pensiamolo semplicemente nel ruolo che interpretava (che aveva in un qualche modo acconsentito a interpretare) nel dibattito culturale degli anni '70; pensiamo alle Lettere Corsare: non era una popstar – anzi, meglio, una rockstar – anche lui, quando scriveva “io so” o “vi odio cari studenti”? E la Morante del Mondo salvato dai ragazzini? E Don Milani, non quello asperrimo delle Esperienze pastorali, ma quello edulcorato della vulgata veltroniana, quello che è un eroe perché non boccia gli studenti poveri? E Dario Fo? E Indro Montanelli quando faceva lo storico? Ed Enzo Biagi quando diventava un marchio di fabbrica (garanzia di medietà) da appiccicare su qualsiasi prodotto industriale, compresi i fumetti? Tutto questo succedeva quando Berlusconi faceva al massimo il palazzinaro: non l'ha inventato lui il midcult. In seguito non mi sembra che abbia aggiunto molto a una formula già rodata. Ne ha semplicemente approfittato, come qualsiasi editore (Feltrinelli non lo ha fatto? E Adelphi?)2. F a z i o è i l n u o v o B a u d o. Sono d'accordo. E allora? Secondo me sarebbe d'accordo lo stesso Fazio, probabilmente è il disegno che persegue da anni. A questo punto però propongo un esercizio intellettuale: immaginare cosa sarebbe Domenica In, il contenitore domenicale della Rai, se lo gestisse Fazio da dieci anni, come probabilmente sarebbe successo senza editti praghesi e in generale senza Berlusconi al potere. Non c'è dubbio che lo avrebbe gestito come lo gestiva Baudo negli anni Ottanta: invitando cantanti e scrittori, presentando balletti cantanti e telefilm, e dando verso sera la linea a 90° minuto. Secondo me Fazio ha sempre voluto essere quello lì, quello che regna sulla domenica italiana. E non c'è dubbio che sarebbe una domenica nazionalpopolare, ma che domenica sarebbe? Un'intervista a Peter Gabriel (all'ora in cui invece si parla del delitto di Avetrana), un siparietto con Albanese (invece che Platinette), due chiacchiere divulgative con Odifreddi (invece di un servizio sulla fine del mondo nel 2012), un balletto ma sperimentale, poi un'ospitata di Follett o Calasso che presentano il loro cartonato (invece di un servizio dalla casa del Grande Fratello). Che domeniche sarebbero? Naturalmente noi avremmo meglio da fare che guardarlo – ma non sarebbe un netto miglioramento, non solo nei confronti della merda che affligge la nostra digestione mentre sonnecchiamo sul divano, ma anche rispetto alla Domenica baudiana? Insomma, preso atto che Fazio è il nuovo Baudo, è così male come Baudo? Baudo non invitava la Fallaci o Pasolini, è arrivato troppo tardi: ma non è neanche riuscito a scovare Pier Vittorio Tondelli o Andrea Pazienza. Io ricordo immarcescibili i vari Bevilacqua, Gervaso, De Crescenzo, Luca Goldoni, per carità tutta gente simpatica, ma non stiamo neanche a scomodare il termine popstar. E invece un Pazienza da Fazio ci sarebbe andato. E gli avremmo dato del nazionalpopolare. Perché saremmo convinti di vivere in una pessima Italia, non sapendo quanto è pessima quella in cui Berlusconi ha vinto e la domenica è affidata a creature come Giletti, o Giurato.
3. L e c e n e r i d i G r a m s c i. Per l'apocalittico Trocino l'apparizione di queste popstar è un chiaro sintomo degenerativo della cultura di sinistra (ogni tanto compare Gramsci come nume tutelare, per la verità la riflessione di Gramsci sul nazionapopolare era un po' più sottile). Ora, dare addosso alla sinistra è uno sport nazionale che pratico anch'io a livello amatoriale (ma da bambino sognavo il professionismo). Però, insomma, chi ce lo ha detto che Allevi è di sinistra? Lui no, lui non lo ha detto. Da cosa si dovrebbe capire? E Mauro Corona? Non potrebbe essere considerato più agevolmente un autore di destra, col suo primitivismo apocalittico? A volte, più che essere di sinistra, queste popstar “vengono” dalla sinistra: vedi Petrini, con la sua storia di comunista di sezione. Trocino poi insiste molto sui 'tradimenti' di Petrini, sui suoi flirt con la Lega. Si potrebbe semplicemente prendere atto che il fondatore di Slow Food, partendo da sinistra, si è spostato consapevolmente su posizioni conservatrici che lo portano per forza a incrociarsi con movimenti tradizionalisti e identitari. Lo stesso Saviano, prima che con “Vieni via con me” si ritrovasse nella ridotta televisiva antiberlusconiana, godeva di una certa trasversalità politica, secondo Facci e Socci era addirittura un intellettuale di destra (a proposito: e Socci? Non è a suo modo una popstar, anche se più locale, diciamo un neomelodico della parrocchietta? E Veneziani? E Buttafuoco? E chi li legge? Sì, appunto, è il solito problema della cultura italiana di destra, che non trovi nessuno disposto a leggertela, figurati a passarti i riassunti). Il fatto che da sinistra spuntino più popstar dipende se mai dal fatto che sempre di consumo culturale stiamo parlando, e il bacino di questo consumo è sempre il famoso ceto medio riflessivo coi capelli grigi che intasa le librerie Feltrinelli alle sei di pomeriggio di ogni santo sabato: i libri e i dischi li comprano praticamente solo loro (per dire io Trocino l'ho preso in biblioteca), quindi è abbastanza naturale che oggi le popstar nascano lì. Ma non restano lì, questo mi sembra importante. Si diventa popstar quando si riesce a sfondare il proprio bacino tradizionale e a piacere anche a tutti gli altri. Lo stesso Camilleri, prima di darsi alle invettive impegnate, ha conquistato la sua popolarità sulla cosa più trasversale che esista sui banchi del mercato letterario: il giallo seriale. Roba tendenzialmente conservatrice, non fosse perché di solito la Legge trionfa e l'Ordine viene ripristinato: salvo che in quegli anni c'è stata un'enorme rivalutazione del noir da sinistra, che ha permesso a Camilleri e ai suoi lettori di non percepire quel senso di colpa – ma anche quel delizioso senso di proibito – che avevano i 'compagni' di trent'anni fa che sfoggiavano Marcuse sugli scaffali del soggiorno ma sul comodino ammucchiavano Gialli Mondadori. C o n t i n u a . . .
Fiori per Algernon
11-07-2008, 17:43apocalittici e integrati, Berlusconi, raccontiPermalink Carteggio
Carteggio2/6/1994
Mio caro Algernon,
ho letto con attenzione e (non lo nego) qualche difficoltà la tua dissertazione in cui azzardi una sintesi di Horkheimer e Debord nel tentativo di offrire una chiave interpretativa filosofico-sociologica alla recente vittoria elettorale di Silvio Berlusconi. Come sempre il tuo pensiero è solido e articolato, forse troppo articolato, al punto che mi sorprendo talvolta a chiedermi se tanta complessità sia realmente utile alla decostruzione dell'avvento al potere di una plutocrazia mediatica nel vuoto creato dall'esaurimento della guerra fredda. Concordo sul fatto che siamo di fronte a un'involuzione culturale prima che politica, di fronte alla quale dobbiamo fare appello a tutte le nostre risorse intellettuali: ma ho la sensazione che la discussione non possa, e non debba, rimanere confinata in un ambito precipuamente accademico. Perdonami la fretta, ma mi riprometto di tornare su questi argomenti assai presto in futuro.
15/9/1996
Caro Algernon,
Ho ritrovato proprio oggi tra le mie carte la bozza di un vecchio biglietto di due anni fa in cui velatamente ti rimproveravo di un linguaggio troppo accademico e usavo, credo per la prima volta, il termine “involuzione culturale”. Come vedi la nostra discussione prosegue ancora intorno allo stesso problema, che credo di poter sintetizzare così: in questi anni di volgarizzazione indotta delle masse pilotata dallo strapotere mass-mediatico, in che misura noi intellettuali possiamo rompere il “guscio” accademico e tornare a parlare a quelli che non si sentono coinvolti dai nostri discorsi, la cosiddetta (perdonami il termine vago), “gente”? E non rischiamo coi nostri tentativi, di rimanere intrappolati proprio in quella involuzione che stigmatizziamo? Magari al convegno in gennaio avremo l'opportunità di approfondire il problema.
22/10/1998
Caro Algernon,
non credevo che la caduta di Prodi mi avrebbe tanto turbato. Sento che la mia profonda avversione per Berlusconi e per tutto ciò che rappresenta nella storia d'Italia – chiamiamolo pure “berlusconismo” - mi trasforma talvolta in un vero e proprio tifoso, impedendomi di analizzare i fatti con la razionalità necessaria. Mi sorprendo a definire Bertinotti un “traditore” - una parola che non faceva parte del mio lessico, decisamente, e a evitare il mio verduraio di fiducia, noto forzista, unicamente perché temo i suoi sfottò, proprio come se si trattasse di una contesa sportiva, e non di un lento processo storico che avrà ripercussioni sul futuro dei nostri figli. E d'altro canto, se in quattro anni di critica a Berlusconi non sono nemmeno riuscito a convincere il mio verduraio, la responsabilità non è forse mia? Rileggo le lettere che ci scambiamo tre o quattro anni fa, e scopro nei nostri discorsi un eccesso di astrazione che mi fa vergognare. Citavamo Horkheimer e Debord, e nel frattempo Lui si faceva le leggi su misura – quanto siamo stati stupidi.
Da: gcharlie69@altavista.com
Inviato il: 10/12/2000 14:36
A: algernon71@yahoo.com
Ciao Algernon
Totalmente d'accordo con quanto scrivi. Rutelli o chi per lui non hanno la minima speranza: Berlusconi ha già vinto. E però anche stavolta mi sembra il caso di fare un'autocritica: cosa abbiamo fatto noi cosiddetti “intellettuali” in questi anni per convincere la gente che Berl era il male?
Quanto tempo abbiamo perso in discussioni astratte e oziose invece di uscire nelle piazze e denunciare a gran voce il monopolio televisivo-editoriale, le collusioni con la mafia, la corruzione dei giudici, ecc. ecc.? E allora è inutile che ci lamentiamo adesso. Alla prossima.
Da: gcharlie69@altavista.com
Inviato il: 10/5/2002 00:41
A: algernon71@yahoo.com
E no, Algernon, mi spiace, ma non puoi trattare il movimento no-global o no-war o come vuoi chiamarlo alla stregua di una massa di ignoranti. La loro critica all'apparato industriale-bellico-mediatico, per quanto rozza, è sacrosanta, ed è nata dal basso, finalmente. E gli stessi girotondini, con il loro culto sicuramente un po' acritico della Costituzione, esprimono una voglia di legalità e di giustizia che non puoi liquidare. Questa è finalmente un'Italia che protesta, che reagisce, cazzo. Sì, ho proprio scritto cazzo, hai letto bene. Scusa, ma questa discussione mi sta infervorando.
Da: gcharlie69@gmail.com
Inviato il: 10/5/2004 23:26
A: algernon71@yahoo.com
Il fatto, Algernon, è che in questi ultimi anni io mi sento sopraffatto dallo schifo. Schifo per la Guerra del signorino Bush, schifo per il nostro regime da operetta, per il Nano e per le Ballerine, e non ho tempo, e se avessi il tempo non avrei voglia, per produrre analisi articolati, lunghi discorsoni e quella roba lì. Cioè, di fronte a una come la Fallaci che bercia, secondo me l'unica analisi che mi sento di fare è “Taci stronza”: davvero, c'è altro da aggiungere? Del resto perché lei può usare le parolacce e io no?
Da: gcharlie69@gmail.com
Inviato il: 23/9/2006 12:34
A: algernon71@yahoo.com
Sai cosa c'è, Alge? C'è che il mortadella è una grossa delusione... neanche per colpa sua, poverino...
lui ci prova a governare, ma deve dare un contentino al cinghialone Mastella... un altro a Di Pietro... che è un po' come la botte piena e la moglie ubriaca, no? E poi ci sono i rifondaroli, i comunisti italiani, i verdi coi loro no-tav e no-qui e no-là, i gay, le lesbiche, il trans... insomma, più che è un governo è il carnevale... e dietro l'angolo c'è il Nano che è già pronto a mettercela in culo... cosa che evidentemente ci piace... e allora un intellettuale cosa deve fare? A me certe volte la sera vien voglia di uscire in terrazzo e gridare... Gridare cosa? Non so, probabilmente... probabilmente un gran vaffanculo... che non risolve i problemi, però.... ti sfoghi...
Da: gcharlie69@gmail.com
Inviato il: 9/7/2008 12:34
A: algernon71@yahoo.com
E allora VAFFANCULO anche a te Alge, VAFFANCULO. Non ti è piaciuto l'otto luglio? E allora lasciati pure governare da un NANO PELATO CHE PIPPA e manda al governo le POMPINARE, ai capito bene, le POMPINARE, e tutta la corte di STRONZI compresa l'opposizione ombra di TOPO GIGIO che e dà trentanni che studia politica e NON A ANCORA CAPITO UN CAZZO come te del resto. Vaffanculo, va.
(Continua? Può continuare così?)
ridete, pagliacci
06-07-2007, 02:02apocalittici e integrati, società dell'avanspettacolo, sogniPermalink Per la società dell'avanspettacolo è stata una settimana difficile. Il palco scricchiola, il pubblico sonnecchia, il sipario è smandrappato e rischia di venir giù tutto d'un tratto.
Per la società dell'avanspettacolo è stata una settimana difficile. Il palco scricchiola, il pubblico sonnecchia, il sipario è smandrappato e rischia di venir giù tutto d'un tratto.Su Piste ho messo insieme tre episodi che non hanno apparentemente nulla in comune, eppure:
- A Siena non riescono più a mettersi d'accordo nemmeno su chi ha comprato il Palio.
- A Parigi John Galliano trascina l'Alta Moda Internazionale nel solito carrozzone disneyano.
- A Torino, per scartare il nuovo giocattolino di Lapo e lapoidi, una compagnia di sosia di Vip e acrobati demotivati rifrigge per l'ennesima volta la Storia d'Italia per luoghi comuni.
Tutto questo potrebbe voler dire una cosa sola: non riusciamo più a divertirci. L'Occidente è in quella fase crepuscolare dell'adolescenza in cui appoggiato al muro di un locale con un bicchiere in mano ti rendi conto che non ti piace la musica, non ti piace la compagnia, non ti piace nemmeno il Gin Tonic, che l'abitudine ha preso da un pezzo il sopravvento sul piacere. E la colpa di chi è? E se fosse colpa del Dj? La solita scaletta, invariata da cinquant'anni, non dice niente della nostra vita.
Questa classe dirigente fa schifo per vari motivi, e forse il primo è che non ha fantasia. Ricicla persino i sogni dei papà e dei nonni. Scusate, ma che tipo di nostalgia dovremmo provare davanti a una Cinquecento a diecimila euro? Ma ridateci una Panda a cinquemila, e ai sogni ci penseremo noi.
ogni allarme è ingiustificato
26-04-2007, 01:26apocalittici e integrati, racconti, riscaldamentoPermalink La versione di P.P.
La versione di P.P.Chi sia il furbo, chi sia il fesso, ancora oggi non lo so.
Quando ti parlavo di Effetto Serra, tu mi prendevi per matto: non c’è nessun Effetto Serra, non c’è nemmeno la prova che il pianeta si sia riscaldando, usiamo un po’ il buonsenso, perdìo.
Poi è arrivato un uragano, e tu hai detto che un uragano non fa statistica.
Allora è arrivato un altro uragano, e tu hai detto che statisticamente è già successo, nel dodicesimo secolo, che ci fossero due uragani, embè? Ma usiamo un po’ il buonsenso.
Poi c’è stato lo Tsunami, che col clima c’entra nulla, e tu mi hai detto: Visto? L’Effetto Serra non c’entra nulla. La gente ai tropici muori anche senza. Lo vedi, PP? Tutto questo allarmismo è ingiustificato.
Poi ci sono stati altri uragani, e alla fine lo hai ammesso: il pianeta è un po’ più caldo. Ma chi ha detto che sia colpa dell’uomo? Eh? Ci sono studi seri che lo provano?
Poi sono usciti gli studi seri che lo provavano. E va bene, hai detto. Sarà anche a causa dell’uomo che fa un po’ più caldo – ma chi ha detto che sia un male? Basta con il vecchio buonsenso, perdìo.
Pensiamola diversamente. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia! Proviamo a considerare il riscaldamento globale una risorsa. Pensa a quante isole nuove, a quante mete turistiche da scoprire. Pensa al Passaggio a Nordovest, a Nordest. Pensa al turismo antartico. E tutto questo è merito dell’uomo! Non ti fa sentire quasi un Dio?
Io ci pensavo un po’ e poi dicevo: mah. Può darsi che a qualcuno il riscaldamento globale porti fortuna, ma per la maggior parte dell’umanità sarà una disgrazia. La fascia maggiormente sconvolta sarà quella subtropicale, dove abita più gente e la più povera. Se si alza il livello del mare non potranno rifugiarsi in Groenlandia. Se il suolo si desertifica, non potranno acquistare cereali dalla Russia. Insomma, Martin, il bilancio resterà in passivo. E tu: sciocchezze, PP. La verità è che tu, questa catastrofe, te la sogni di notte. È da tanto tempo che la immagini che ne hai fatto una malattia, come lo scudetto dell’Inter. Faresti carte false pur di aver ragione. È diventata una questione tra te e il mondo! Senza una carestia o un diluvio, non sei contento. Sei proprio convinto di avere a cuore l’interesse dell’umanità? Non è che ne hai abbastanza, di questa umanità, non è che preferiresti annegarla tutta e ricominciare da capo? Ma chi sei, Noè?
Io ci sono rimasto un po’ male, perché in fondo chissà, può anche darsi che tu avessi ragione. È un po’ un’ossessione, la mia. La gente di buon senso non pensa sempre alle catastrofi. Non si fascia la testa a ogni cattiva notizia. La gente di buon senso.
Poi si è seccato il Po, il comune ha iniziato a razionare l’acqua corrente, quella minerale è aumentata del 5000%, e io sarei stato curioso di sentire il tuo parere. Ma tu te n’eri già andato nella tua nuova villetta in Canada, comprata con la liquidazione del negozio di articoli da sci alpino.
Da quel che so ti sei fatto un giardino con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà, e le ragazze si fermano ai cancelli ad ammirarla.
E insomma, chi è il furbo, chi è il fesso, non lo so. La notte – quando non sono di turno alla pompa dei nuovi argini - sogno di venirti a trovare, e a incendiare la tua casetta bella. Ah, sì, lo so che laggiù hai tutto lo spazio che vuoi per costruirne un’altra. Ho sentito che ogni anno si libera dai ghiacci più terra di quella che si è impaludata in un mese qui, in valpadana.
Terra verde, terra fresca, terra vergine.
Goditela, Martin, finché puoi. Sto arrivando.
Tuo,
Pinco Panco.
(Non nascondetevi sotto la sabbia! Studiatevi le opportunità di un sano riscaldamento globale! via Wittgenstein)
Lettere Vitruviane #5: Sulle mezze stagioni, che scompaiono
02-01-2006, 01:46apocalittici e integrati, crisi? che crisi?, riscaldamento, Sacripante!PermalinkCaro Leonardo, hai notato che le mezze stagioni non sono più quelle di una volta? Secondo te di chi è la colpa? Rispondi con franchezza.
BernH ‘73
Caro BernH, capisco e condivido le ragioni del tuo turbamento. Mi scrivi da un settembre freddo e plumbeo, uragani alla tv, e mi chiedi conto del settembre d’una volta, del crepitare delle prime foglie secche nel cortile della scuola, e hai visto che due tette ha messo su la Mirella? Era, il tuo vecchio settembre, un terrazzino mite sulle nebbie e i geli dell’autunno-inverno; sapeva di mosto e di libri nuovi. Ora sgualciti in un cartone in soffitta, scarabocchiati, invendibili. Il boiler gorgoglia, tra un poco sarà tempo di mettervi mano. Muovere la rotellina da ESTATE (sole raggiante) a INVERNO (fiocco di neve). Il riscaldamento autonomo non contempla mezze stagioni, e tu mi chiedi di chi è la colpa.
Vorrei poterti dire: è stato George W. Bush, sempre lui. Ma parliamoci chiaro, BernH. Noi non siamo i primi due sulla terra a lamentarsi delle mezze stagioni d’antan. L’emergenza climatica ha appassionato generazioni e generazioni. Ne ho avuto conferma rileggendo, qualche giorno fa, un post di Giacomo Leopardi, datato gennaio 1828. Ferveva a quei tempi il dibattito sul raffreddamento globale: insigni scienziati si chiedevano se non fosse in qualche modo colpa dell’uomo. Leopardi scienziato non era, ma aveva questa mania fastidiosissima di dir la sua (non interpellato) su qualsiasi argomento. Riguardo alle mezze stagioni, egli copia e incolla a sua volta un post scritto 144 anni prima (e siamo già nel 1683…) in cui un tal Magalotti si lamenta “che l’ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi...
“Qui in Italia è voce e querela comune che i mezzi tempi non vi son più, e in questo smarrimento di confini, non vi è più dubbio che il freddo acquista terreno. Io ho udito dire a mio padre che in sua gioventù a Roma, la mattina di pasqua di resurrezione ognuno si rivestiva da state. Adesso chi non ha bisogno d’impegnar la camiciola, vi so dire che si guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa di quelle ch’ei portava nel cuor dell’inverno”.
Magalotti, Lettere familiari, parte I. lett. 28. Belmonte 9 Febbraio 1683 Già nel XVII secolo, dunque le mezze stagioni si davano per spacciate. Ma Leopardi minimizza, secondo lui è tutto un problema di ricordanze, come al solito, di nostalgia. Il vecchio, laudator temporis acti se puero [=che loda il tempo della sua infanzia], non contento delle cose umane, vuol che anche le naturali fossero migliori nella sua fanciullezza e gioventù, che dipoi. La ragione è chiara, cioè che tali gli parevano allora; che il freddo lo noiava e gli faceva sentire infinitamente meno, ec. ec. Del resto non ha molt’anni che le nostre gazzette, sulla fede dei nostri vecchi, proposero, proposero come nuova nuova ai fisici la questione del perché le stagioni a’ nostri tempi sieno mutate d’ordine ec. e cresciuto il freddo; e ciò da alcuni fu attribuito al taglio de’ boschi del Sempione ec. ec. Quello che tutti noi sappiamo, e che io mi ricordo bene è, che nella mia fanciullezza il mezzogiorno d’Italia non aveva anno senza grosse nevi, e che ora non ha quasi anno con nevi che durino più di poche ore. Così dei ghiacci, e insomma del rigore dell’invernata. E non però che io non senta il freddo adesso assai più che da piccolo. (Zibaldone di pensieri, 8 gennaio 1827). Di chi è la colpa, dunque? Sarà in qualche modo colpa dell’uomo, che continua a tagliar boschi e trivellare pozzi. E poi è colpa tua, che sudi in un colletto di camicia invece di dar calci a un SuperTele sotto la pioggia. Tu che smadonni per due chicchi di grandine sulla carrozzeria. Mi hai chiesto franchezza, ebbene eccola qui: lascia perdere la mezza stagione. Non è più roba per te. Cordialmente.
JONATHAN FRANZEN, Come stare soli, Einaudi, Torino, 2003 (How to be alone, 2002; traduzione di Silvia Pareschi).
Questo libro vuole essere, in parte, la testimonianza del passaggio da un isolamento rabbioso e spaventato a un’accettazione – persino una celebrazione – dell’essere lettore e scrittore. Non che oggi manchino i motivi per essere arrabbiati e spaventati. (dall’Introduzione).Da apocalittico a (parzialmente) integrato: è la traiettoria dell’intellettuale contemporaneo tracciata da Jonathan Franzen in questa sua scelta di saggi, comparsi su riviste tra il 1994 e il 2001 e raccolti in volume nel 2002. Una traiettoria che il lettore dei suoi romanzi troverà in qualche modo familiare: l’intellettuale Franzen la condivide con alcuni dei suoi personaggi romanzeschi più riusciti. In mezzo al guado, la palude della depressione, motivo esistenziale sul quale l’autore ritorna esplicitamente in più occasioni.
All’inizio degli anni Novanta Franzen sperimenta sulla sua pelle la crisi del progetto artistico su cui ha impostato la sua carriera sin dall’inizio (“Quando finii il college, nel 1981, non ero al corrente della morte del romanzo sociale”). I suoi primi due romanzi, pur riscotendo un discreto successo di critica e di pubblico, non suscitano nessuna reazione a parte “un’altra pagella di buoni voti da parte dei critici […] una discreta quantità di denaro; e il silenzio dell’irrilevanza”. Le statistiche sul calo dei lettori di narrativa, il trionfo della cultura dell’immagine, l’avvento dei profeti “cybervisionari” con le loro previsioni su un futuro interamente digitale: tutto sembra congiurare contro l’antica professione del romanziere. Più in profondità, l’opulenta società americana degli anni Novanta sembra non aspettarsi più nulla dalla narrativa e dall’arte.
Immaginiamo che l’esistenza umana sia definita da un Dolore. […] Se consideriamo la religione e l’arte come i metodi storicamente preferiti per venire a patti con questo Dolore, che ne è dell’arte quando i nostri sistemi tecnologici ed economici e persino le nostre religioni commercializzate sono ormai abbastanza sofisticati da collocare ognuno di noi al centro del proprio universo di scelte e gratificazioni?
La società non ha bisogno di letteratura, ma di narcotici: e ne produce in abbondanza, “sotto forma di Tv, cultura popolare e oggetti di ogni tipo”. Ciò che rende particolarmente efficace la descrizione dei “narcotici” è che l’autore non nasconde di averne fatto uso a più riprese, e di sentirne ancora il bisogno: è il caso, per esempio, della televisione. Come nella miglior tradizione apocalittica, l’apparecchio televisivo è considerato un oggetto diabolico, ma il rapporto che l’autore intrattiene col “vecchio aggeggio ingombrante” nascosto letteralmente nell’armadio, rasenta il grottesco.
Mi chiedo se possa esistere un’immagine più tetra della codipendenza delle centinaia di ore che ho passato con un pezzo di filo di rame tagliente stretto fra indice e pollice per migliorare la qualità dell’immagine del mio televisore.
Può darsi che le pagine apocalittiche di Franzen – quelle in cui l’autore indaga sulla sua depressione, e ne fornisce le coordinate storiche e sociali – siano le più intense: ma nei saggi in cui compaiono sono già rielaborate sotto un nuovo punto di vista. Esemplare sotto questo aspetto la sorte del saggio Perché scrivere romanzi, che ai tempi dalla sua apparizione su “Harper’s” nel 1996 col titolo Forse sognare era stato considerato (per un malinteso) un manifesto del romanzo sociale, da cui Franzen stava piuttosto prendendo congedo: rileggendolo sei anni dopo, l’autore si rende conto che
nei cinque anni trascorsi da quando avevo scritto il saggio, ero riuscito a dimenticare che a quell’epoca ero un individuo molto arrabbiato e con la testa piena di teorie. Il fatto che gli americani guardino tantissima Tv e leggano poco Henry James mi provocava un’angoscia apocalittica.
La “fuga di uno scrittore in crisi dalla prigione dei suoi pensieri rabbiosi” comincia con una scoperta fondamentale: la solitudine. Contattato da una studiosa di scienze sociali che sta conducendo una rigorosa ricerca scientifica sul “pubblico della narrativa seria in America”, l’autore scopre di appartenere sin dall’infanzia a una tipologia di lettore ben definita: l’isolato sociale, che sin dall’infanzia vive la sua esperienza di lettura come dialogo con un “essenziale mondo immaginario”. Questo mondo essenziale non è un rifugio, tutt’altro: nella opere narrative questi lettori riconoscono una sensazione d’imprevedibilità che è un tratto distintivo della loro esistenza (si tratta spesso di migranti, o persone che vivono comunque una realtà molto diversa da quella dei genitori). La buona narrativa descrive i conflitti rifuggendo le facili soluzioni, e tornando sempre sui “problemi fondamentali”.
In fondo, è sempre il vecchio tema del dialogo coi classici: ma Frenzen lo vive come una scoperta liberatoria.
Come potevo non sentirmi estraniato? Io ero un lettore. La mia essenza mi aspettava da sempre, e adesso mi dava il benvenuto. D’improvviso mi accorsi di quanto fossi ansioso di costruire e abitare un mondo immaginario.
Solo ora, deponendo parzialmente le ambizioni del suo progetto di romanzo sociale, Franzen può riscoprire il piacere di leggere e di scrivere dei personaggi e dei luoghi che ama. Il suo terzo romanzo, arenatosi da tempo sotto il peso “del mio presunto dovere nei confronti di una chimerica cultura di massa”, si rimette in moto: si tratta naturalmente di The Corrections, che uscirà nel 2001 (Le correzioni, Einaudi, 2002).
Che cos’è esattamente la solitudine di Franzen? Non sembra avere molto a che vedere con torri d’avorio o ritorni al privato. L’intellettuale non rinuncia a indagare la società in cui vive e a pronunciare sentenze anche molto critiche. Non rinuncia nemmeno, se invitato, a comparire in un talk show televisivo (perlomeno ci prova, com’è testimoniato dal bel racconto autobiografico Ci vediamo a St Louis, dove una troupe televisiva costringe l’autore a tornare nei luoghi dei suoi lutti familiari). Ma la scoperta di appartenere a una comunità extratemporale di lettori e scrittori lo riconcilia coi suoi contemporanei. Non è più costretto a fare concorrenza (una ben misera concorrenza) alla cultura di massa: in fondo l’elitarismo della letteratura è sempre esistito, anche se “si era fugacemente eclissato nel periodo d’oro del romanzo”.
Così il “sublime sdegno” dei tempi di Forse sognare lascia il posto a un tono più bonario nei confronti di una realtà nella quale l’intellettuale progressivamente accetta di vivere, rinunciando a molti eccessi ideologici. Molti saggi raccolti nel volume testimoniano questo mutato atteggiamento. Raccontando la malattia del padre, in quella che è quasi un’appendice alle pagine più autobiografiche delle Correzioni, Franzen ammette di aver rifiutato dapprima l’idea dell’Alzheimer (“mi sembrava un altro aspetto della medicalizzazione dell’esperienza umana”) nel tentativo di salvare un’individualità annullata dalla casistica medica
…mi dispiace vedere il significato personale staccarsi da certi errori di mio padre, come confondere la moglie con la suocera, una cosa che allora mi parve bizzarra e misteriosa e dalla quale racimolai ogni sorta di nuove e importanti intuizioni sul matrimonio dei miei genitori. A quanto pare, il mio senso della personalità individuale era illusorio.
Se nel suo ultimo romanzo Franzen aveva descritto impietosamente l’involuzione liberista della società attraverso lo smantellamento di una compagnia ferroviaria privata, in Lettere smarrite l’argomento è capovolto: si tratta di dar conto del crollo sistemico di una grande azienda pubblica, il servizio postale di Chicago, travolto dalla burocrazia, dalla corruzione e dall’ipocrisia del politically correct. Perfino il vero nemico numero uno della società americana, il “Grande Tabacco”, è affrontato da Franzen con insospettabile tolleranza in Setacciare le ceneri: fumatore pentito ma non redento, Franzen si scopre in un qualche modo solidale con le aziende fornitrici di sigarette, capri espiatori del risentimento popolare, e comunque colpevoli di aver “venduto l’anima ai consulenti legali” (il saggio documenta come la strategia suicida di negare la nocività del fumo fosse una scelta portata fino in fondo dagli avvocati dei produttori). In Unità di controllo Franzen documenta in presa diretta i paradossi di uno dei più fiorenti business americani: l’amministrazione carceraria. Da una parte del muro, i giovani “neri e latini” obbligati a svolgere “per un dollaro l’ora o anche meno, i lavori umili che da liberi si rifiutavano di svolgere per il minimo salariale”; dall’altra parte, gli abitanti della cittadina che ha deciso di ospitare un carcere di massimo rigore, illusi e poi frustrati da una struttura che promette sicurezza ma non dà occupazione.
In altri saggi il nucleo tematico della solitudine diventa riflessione sul concetto (problematico) di privacy: ma anche in questo caso, e in un momento in cui le libertà personali sembrano messe a dura prova dalla pervasività della tecnologia, Franzen spiazza il lettore invertendo i termini della questione: non è la privacy che manca agli statunitensi, anzi: nell’era dei forum elettronici e dell’esplosione dei quartieri residenziali la verità è che “siamo sommersi dalla privacy”. Quello che invece va scomparendo è uno spazio pubblico, “dove ogni cittadino è il benvenuto e dove la sfera puramente privata è esclusa o limitata”. Perciò, paradossalmente, il caso Clinton-Lewinsky, esploso nell’“ultimo grande, poderoso bastione della vita pubblica americana” è l’unica, e definitiva violazione della privacy, mentre l’espansione suburbana ha causato la fine delle “buone maniere”, dei “comportamenti adulti che si imparano meglio in luoghi pubblici come i marciapiedi”. Ma nonostante le spinte centrifughe, la grande città polifunzionale resiste, e rimane il luogo ideale dove imparare a stare soli. È qui che lo scrittore-lettore Franzen decide di restare. A costo di ridursi a razzolare nei rifiuti, come al termine di uno dei pezzi più autobiografici e divertenti, Materiale di recupero. Qui l’arte della riparazione dei vecchi utensili (una macchina da scrivere, una poltrona, un vecchio computer) diventa, più che una sfida al “tecnoconsumismo”, ma una vera e propria metafora della pratica letteraria.
L’obsolescenza è il prodotto principale della nostra passione nazionale per la tecnologia, e io sono ormai convinto che l’obsolescenza non sia un male ma una meraviglia: non la perdizione, ma la salvezza. Più il progresso tecnologico diventa precipitoso, più cresce il volume dei detriti obsoleti. E i detriti non sono soltanto materiali. Sono anche una religione arrabbiata, la rinascita di ideologie controculturali, i nuovi disoccupati, gli eterni disadattati. Tutto ciò garantisce che gli scrittori non saranno mai soli. L’ineluttabile obsolescenza è il nostro patrimonio.
(La versione on line di Forse sognare l'ho trovata grazie a FaM).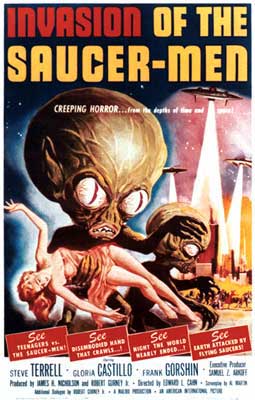 Ceronetti contro le sanguisughe confederali
Ceronetti contro le sanguisughe confederaliExtra action!
Siamo in guerra – e forse dovremmo avere più pudore nel parlarne, perché rischia di suonare banale, mentre è soltanto vero. Non sappiamo esattamente quando è iniziata, ma già vediamo le nostre stesse vite, qui nelle retrovie, esposte a un peggioramento. Ci accusiamo a vicenda, non ci fidiamo più di nessuno, in piazza ci spiamo… quel signore all'angolo dove l'ho già visto, perché non parla con nessuno, non è per caso qualcuno in borghese? Oggi uscendo dalla mensa un tale si divincolava da due vigili urbani.
Siamo in guerra, e non vale consolarci pensando che la guerra è altrove. La terribile Pasqua palestinese ha pur sempre fatto meno vittime di una normale pasquetta italiana. Verranno un giorno i pacifisti di tutto il mondo a protestare davanti ai nostri caselli autostradali? Siamo al corpo a corpo, tutti contro tutti. Ci fanno molta paura gli albanesi (che guerre non ne hanno forse vinte mai), e intanto ci massacriamo a casa nostra, figli contro madri e fidanzati contro fidanzati.
Nell'ombra aspettiamo soltanto il momento di calare pugnali alle spalle del prossimo. Io stesso, la settimana scorsa, sfogliavo la Stampa, aspettando al varco qualche intellettuale falsopacifista, un succulento Yehoshua, o un prevedibile Lerner (che mi ha spiazzato uscendo invece sul Manifesto). E mentre sfogliavo nell'ombra, domenica 31 – primo giorno d'ora legale, vero inizio di Primavera – ho finalmente visto la luce. Rossa. Non fraintendete. Era un fondo di Ceronetti. I suoi fondi sulla Stampa si chiamano appunto Lanterna Rossa.
Ecco qui:
Di violenze ormai ne subiamo tante da perderne il conto. Da perderne perfino coscienza. Ma è violenza tutto, da tutto, contro tutto e tutti. È assurdo quindi ritenere di vivere nella pace, in luoghi provvisoriamente non visitati dalla peste di una guerra.
Mio Dio, quant'è vero, mi sono detto. Quest'uomo ha colto nel segno. Ecco cos'è questa sensazione di rabbia tutte le sere, questa impotenza, questa frustrazione, questi foruncoli. Siamo in guerra. Ma forse, leggendo il fondo di questo intellettuale, potrò capire qualcosa, mettere un po' di pace almeno nella mia piccola vita. E sono andato avanti.
Tra le violenze accolte con più passività e indifferenza c'è l'imposizione del mutamento di ora due volte nel corso dell'anno.
Un attimo. Ho letto bene? È scritto lì, sul fondo della Stampa, domenica del 31 febbraio 2002. Appena sopra un trafiletto racconta della ragazza sequestrata per nove ore e strangolata da un camionista in seguito a una contestazione amichevole. Più sopra cosa c'è? Cogne, ovviamente, e la Palestina. Morte, morte dappertutto. Pensavo che Ceronetti intendesse questo quando parlava di violenza. Ma no, lui parlava del cambio d'ora. Che c'entra con la violenza?
Nulla è privo di conseguenze nelle profondità medullari dell'essere: essere brutalmente strappati al Tempo Solare alla fine di ogni mese di marzo è un graffio nell'anima, una lacerazione nei tessuti invisibili. [oh, mi piacerebbe citarlo tutto…] L'Autorità – cieca, idiota, volgare, ubbidiente ai più bassi criteri di praticità materiale – interviene dall'alto, afferra la luce che ha appena aperto gli occhi e la stupra, la strangola e ne sotterra il cadavere innocente.
In segreto l'Ora Solare, stremata dall'annuale violenza che patisce, piange.
Oddio, piange, la povera Ora Solare! E io che non me n'ero mai accorto, perché, perché tanta insensibilità? Perché andare a contare i morti di un conflitto lontano quando ho accanto a me questo stupro, questo strangolamento, questo pianto, e nemmeno me ne accorgo? Il fatto è che ormai devo aver perso il contatto con le profondità medullari del mio essere. Vado a letto alle tre, mi alzo alle sei (del mattino), nel dopopranzo quando possibile mi corico un po', non faccio altro che graffiare e lacerare i tessuti invisibili, poi di cosa mi lamento.
Io lo so cosa pensate. Che Ceronetti è il solito piagnone apocalittico, che ciarla ciarla e non ha nessuna proposta concreta e praticabile. Sbagliato in pieno. Sentite un po':
Un'osservazione sul risparmio energetico, pretesto fondamentale per sradicare la fetta europea di umanità dal tempo legittimo del sole. È un incessante eruttare di partite calcistiche e altre esibizioni notturne, in campi e stadi rischiarati da centinaia di riflettori di enorme potenza […] per la mania televisiva di farle di notte, tenebra su tenebra. Spostandole tutte indistintamente in ore diurne, avremmo probabilmente coperto l'entità del risparmio indotto dall'ora legale.
Capito? Altro che ciarlatano. Anche se ha il buon gusto di schernirsi con un "probabilmente", Ceronetti avrà senz'altro in tasca uno studio di fattibilità per provare la fondatezza di quello che dice. Altrimenti non lo scriverebbe su un giornale serio, no? Quindi basterebbe abolire i posticipi di campionato e qualche altro concerto per risparmiare sei mesi di Ora Legale. Beh, sorprendente, questo Ceronetti. Come intellettuale lo trovo un po' sottostimato. Non si riesce a trovargli neanche un sottosegretariato ai Lavori Pubblici, o – faute de mieux – alla Cultura? Chi sa che non abbia nel cappello anche la soluzione ad altre priorità del governo, come per esempio le mezze stagioni (non ci sono più quelle di una volta), o il fatto che una volta qui era tutta campagna…
Ma no. Non lo vedo a ingrigire in un opaco ministero. Ceronetti è un leader, un trascinatore. Sentite questo crescendo finale:
Tanto per sognare. La nube di imbecillità che coprirà l'Italia il prossimo 16 aprile con lo sciopero generale voluto dalle smisurate sanguisughe confederali ecco di colpo -– divina metamorfosi – è trafitta da un raggio di intelligenza tardiva, e diventa sciopero generale contro la violenza alla luce solare, contro la barbarie dell'ora stravolta, e le piazze si riempiono di quadranti, in cui l'ora è fatta ritornare indietro e centinaia di bocche gridano: "Non la toccate più".
Signori, è nato un leader. Voi sciocchi confederati, che ancora vi ostinate a scioperare per quattro ridicoli diritti, non l'avete ancora capito? L'articolo 18 non è il segreto della felicità. Se aveste la forza di guardare nelle profondità medullari dell'essere vostro lo sapreste da tempo, ma siccome avete il cattivo gusto di puntare la sveglia tutte le mattine per andare a lavorare, comprate almeno la Stampa e fatevelo spiegare da Ceronetti: "la barbarie dell'ora stravolta", ecco qualcosa per cui vale veramente la pena lottare.
***
 Siamo in guerra – e in guerra è lecito scherzare, anzi si ride e si canta con più ostinazione che in tempo di pace, perché ce n'è più bisogno. Si ride di quel che si può, anche di un nonnulla, dell'anziano signore che viene al bar e ogni giorno ce l'hai con qualcuno, e sentissi come gliele canta.
Siamo in guerra – e in guerra è lecito scherzare, anzi si ride e si canta con più ostinazione che in tempo di pace, perché ce n'è più bisogno. Si ride di quel che si può, anche di un nonnulla, dell'anziano signore che viene al bar e ogni giorno ce l'hai con qualcuno, e sentissi come gliele canta."Con chi ce l'hai stavolta, Guido?"
"Tès, valà, che stasira mi tocca dormire un'ora in meno, roba da matt! Ma dove andremo a finire?"
"Ma è per il risparmio energetico, Guido!"
"A t'al dag me, il risparmio energetico! Con tutta quelle partite che fanno tutte le sere, al campionato, e poi la ciamponslig, c'la roba lè… tutti quei riflettori accesi per niente, milioni, miliardi... e Berlusconi che non dice niente, e D'Alema… e quel altro là, veh, Cofferati…"
"Son tutti dei ladri, eh, Guido?"
"Tutti, tutti, dal prèm a l'ultèm. E a me tocca puntar la sveglia un'ora prima, tutti gli anni. Roba da matt".
"Ma Guido, scusa, dov'è che hai da andare, c'hai mica un cartellino da timbrare te, no?"
"L'è l'istess! È il principio che conta. Ma lo sai che svegliarsi prima fa male alla salute?"
"Dai, Guido, vieni, ti offro qualcosa".
"O, a'n'deg menga ad no!".
Questi anziani signori ci sono in tutti i bar di tutti i paesi, e in tutte le redazioni dei giornali rispettabili. Perché c'è la guerra, è vero, ma questo non c'impedisce di divertirci ogni tanto alle spalle di qualcuno. Al Corriere c'è la Fallaci, con le sue memorabili smargiassate: "e allora gli ho detto ad Arafat, ma chi ti credi, oh, guarda che i numeri ce li avevano anche i Romani, ed erano anche più dritti dei vostri". Alla Stampa c'è Ceronetti, con la sua Lanterna Rossa. Che bisogna fare? Compatirli? E perché? Sono ridicoli, d'accordo, uno spettacolo pietoso, ma guadagnano bene. Guadagnano molto di più ora da rimbambiti che ai tempi in cui avevano ancora qualcosa di sensato da dire. Non resta che divertirsi anche noi alle loro spalle. In attesa che il prossimo efferato delitto, il prossimo incidente, il prossimo attentato ci riportino alla triste attualità Ma fino ad allora… Dai Oriana, raccontaci di quella volta che tu e Kissinger…















